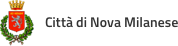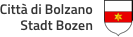Nota sulla trascrizione della testimonianza:
L’intervista è stata trascritta letteralmente. Il nostro intervento si è limitato all’inserimento dei segni di punteggiatura e all’eliminazione di alcune parole o frasi incomplete e/o di ripetizioni.
D: C’era una canzone che voi cantavate nel campo?
Mariuccia: Sì, c’era una canzone che era il rifacimento di una canzone di moda. Il rifacimento delle parole.
Rosetta: L’aveva fatta Funaro, lei non ha mai sentito parlare di Funaro? Era un… aveva delle orchestre.
D: Importanti?
Rosetta: Importantissime.
D: Ed era anche lui un deportato lì con voi?
Rosetta: Sì, era un ebreo.
Mariuccia: Sì, è partito in ottobre, in mutande.
Rosetta: No, in novembre, forse.
Mariuccia: Sì, insomma, una delle prime partenze, completamente in mutande.
Rosetta: E allora noi con Funaro, con grande ira delle guardie, lui Funaro si nascondeva nella nostra cella, ti ricordi? Veniva e si nascondeva in modo che lo avvisavamo quando c’era una guardia, lui si metteva dietro un castello e stava lì ad aspettare, e poi noi lì delle celle ad un certo punto ci mettevamo insieme, lui ci dirigeva e cantavamo la canzoncina.
D: E com’era questa canzone, ve la ricordate?
Rosetta: Sì, sì.
Mariuccia: Era una canzone che nella realtà diceva: “Tutto passa e si scorda, tutto deve finir, è partito il mio amore” qualcosa di simile.
Rosetta: E invece la parodia era: “Tutto passa e si scorda, tutto deve finir, se verrà l’armistizio, ce ne andremo di qui”. Della tuta con croce, un pacchetto farem”
D: Va avanti, però!
Mariuccia e Rosetta: Ed ai repubblichini, volentier la darem. Proveranno la sveglia, delle cinque al mattin, proveranno il buiolo, proveranno il frustin. Non ve n’è più di tedeschi, fame non avrem più, scorderemo l’appello, se torniamo laggiù. Fine.
D: Non vi hanno mai scoperte a cantare?
Mariuccia: Sì, ci picchiavano nella cella col calcio del fucile.
Rosetta: Ma guardi che questa era una roba da bambini, eh? Lei ci fa fare…
Mariuccia: Ma la cantavano tutti.
D: Non è una cosa da bambini, aveva un significato. Era molto eversivo dentro lì.
Mariuccia: Sì, però, era molto eversivo, però se lei si mette in un posto con tremila o quattromila persone che vanno in giro canticchiando così, magari in cinque o sei, poi quando arriva la guardia tedesca smettono, cosa vuol fare? Non era proibito né ridere né canticchiare. Se uno aveva la forza di farlo. E poi comunque si cantava sottovoce.
Rosetta: Aveva un profondo significato. Poi loro forse non capivano.
Mariuccia: Non è che si facessero i cori.
Rosetta: No, ma Mari, non proprio sottovoce perché cantavamo in dieci, dodici persone, e quelli che non potevano uscire dalla cella cantavano dal buco, dallo spioncino.
D: Quindi si era diffusa subito questa canzone?
Mariuccia: Sì, ma era una canzone praticamente molto in voga in Italia, allora. Io le parole della canzone reale non le ricordo, però è facile trovarle.
Rosetta: E penso che l’avesse scritta lo stesso, l’avesse composta lo stesso Funari.
Mariuccia: Funaro? Può darsi.
Rosetta: Ho detto Funari? Per l’amor di Dio, mi correggo: Funaro.
D: Ma ditemi un po’, sorelle, come mai voi siete finite in Via Resia, a Bolzano, quando, perché?
Rosetta: Siamo finite a Bolzano, perché mio marito, che era stato arrestato a Genova dalla Gestapo, faceva parte di una missione….
D: Suo marito è stato arrestato a Genova?
Rosetta: Sì, a Genova, dove stava lavorando con altri che facevano parte di questa missione alleata, e poi dopo aver passato un giorno nella casa di questo studente era stato trasportato nelle celle sotterrane della Gestapo di Verona.
D: Quindi da Genova a Verona.
Rosetta: Sì, alla Gestapo di Verona. E lì proprio per una fortuna incredibile, inspiegabile, mentre lo facevano lavorare per scaricare delle carte che i tedeschi stavano ammassando perché cominciavano a partire, Firenze non era stata occupata allora, gli alleati erano poco sopra Roma ma erano ancora abbastanza lontani. Comunque quel giorno, lui che non avrebbe dovuto assolutamente uscire dalla cella, per uno sbaglio del maresciallo che faceva servizio, è uscito e lo hanno mandato in un garage lì vicino alle celle a scaricare un camion. Lui ha aperto una porta, ha visto che c’era un finestrino, ha visto che il salto era di circa due metri e mezzo o tre metri, si è buttato ed è scappato.
D: Da Verona?
Rosetta: Sì, lui è scappato l’11 settembre.
D: Del ’44?
Rosetta: Del ’44 e la mattina del 12 settembre, alle cinque, sono venuti nella casa di campagna di mio padre, che si chiama “Il Ronco”, sono venuti, è venuto un tenente della Gestapo che mi pare, me lo hanno detto quelli della Digos, si chiamava Martin Engmann, insieme con altri soldati, quanti soldati saranno stati? Tre o quattro.
Mariuccia: Tu stai parlando del Ronco? C’era uno che si chiamava Otto, io di Martin Engmann non so niente.
Rosetta: Il tenente si chiamava Martin Engmann.
Mariuccia: Che è venuto al Ronco?
Rosetta: Sì.
Mariuccia: Comunque lui si è presentato, era un capitano che si chiamava Otto.
Rosetta: No, non era, ah, c’era anche un capitano?
Mariuccia: C’era un capitano che si chiamava Otto, quello me lo ricordo come fosse vero oggi, e ti spiego anche perché. Tu puoi dire di no, ma io questa volta insisto. Perché poi quando io sono ritornata alla SS di Brescia, il capitano Otto, che io credevo si chiamasse Otto, non mi ha mica fatto vedere la carta d’identità. Non si è neanche presentato. Mi ha detto, mi ha chiesto come si stava a Bolzano. E io, in presenza di lui e di quello che era seduto dietro al tavolo, che noi credevamo fosse Leo, ma non si sa chi fosse…
Rosetta: Ma dove, qui a Brescia?
Mariuccia: A Brescia, gli ho detto: “Si stava benissimo”. E loro mi hanno guardato un po’ stupiti, però quel capitano Otto, come mi ha visto entrare nel comando delle SS di Brescia mi è venuto incontro, sorridendo e quasi contento perché mi vedeva lì ancora in carne e ossa, penso. E sono sicura che si chiamava Otto, perché l’ho scritto in due o tre appunti che ho preso.
Rosetta: Di nome o di cognome?
Mariuccia: Lui si è presentato come Otto, dopo poi che si chiamasse Martin Engmann io non lo so. Era chiamato Otto, tu sai benissimo che le persone hanno dei nomi e poi hanno dei nomignoli, diciamo. Ecco, questo sono sicura. Che poi fosse Martin Engmann forse quelli della Digos lo avranno poi appurato in seguito. Lì da noi lui si è presentato come capitano Otto e le dico anche perché: perché mio padre cercava d’ammansirlo, perché inizialmente era piuttosto arrabbiato e gli offriva la colazione, gli offriva, così lui si è seduto a mangiare, ha detto che si chiamava Otto, immagino fosse il nome, il prenome, insomma ha fatto colazione, si è ammansito, poi siamo andati via, si può dire in rapporti cordiali, ecco.
Rosetta: Sì, ci hanno internato.
D: Ah, vi hanno preso subito lì al Ronco?
Mariuccia: Aveva l’espressione di uno fortemente disturbato dal compito che gli avevano dato, questa è la mia impressione, e non l’ho più dimenticata. È un’impressione.
D: Quindi sono venuti il giorno dopo, praticamente?
Rosetta: La mattina alle cinque, quattro e mezza o cinque, ho sentito dei passi pesanti, sono andata alla finestra e ho visto che giù nel prato davanti a casa e sul terrazzo c’erano, al primo momento ho pensato che fossero i soldati della Todt che lavoravano lì di fronte, poco lontano. Ma poi ho guardato, ho visto che avevano i gambali rigidi e ho detto: “No, qui è tutta un’altra categoria di soldati”. Allora ci siamo alzati, siamo scesi, loro hanno cercato subito il bambino perché io l’avevo lasciato su e lo avevo coperto. Pensando che era meglio se non lo vedevano; invece loro mi hanno chiesto se ero la signora Bonomelli, ho detto di sì. “Dov’è il bambino?” Io non ho risposto niente, e loro mi hanno fatto tornare di sopra e hanno scoperchiato, io ero in una stanza, in un lettino c’era mio figlio e nell’altro io, loro hanno scoperchiato lo hanno visto e lui che era già stato piuttosto scioccato per altre circostanze, era stato scioccato perché avevano sparato a suo nonno con lui in braccio. E lui era stato ferito di striscio, nel vedere questi in divisa è diventato un pezzo di ferro, e poi, niente, ci hanno incolonnati e a piedi da lì siamo andati in piazza a Iseo, vero? Poi siamo andati su in municipio, ti ricordi Mariuccia?
Mariuccia: Sì, sì quello mi ricordo molto bene.
D: In casa chi si trovava in quel momento?
Rosetta: In casa c’era mio padre, mia madre, mia sorella, mia suocera, mio figlio ed io.
Mariuccia: E i contadini che abitavano lì, nella stessa casa, in un settore, sa? Era una cascina praticamente di campagna. In una metà ci stavamo noi a fare le vacanze nell’altra metà abitavano i contadini.
D: E vi hanno presi tutti?
Mariuccia: Tutti.
D: L’accusa qual era? Vi hanno presi perché?
Rosetta: Ah, non ci hanno detto niente. Assolutamente. Anzi, noi eravamo molto preoccupati, perché non sapevamo assolutamente il motivo per cui ci avessero preso. E mentre camminavamo a piedi, e stavamo andando in paese, all’altezza del cimitero d’Iseo, io ho visto che dalla parte opposta della strada venivano due donne.
Mariuccia: Le Tanzi, erano.
Rosetta: Le ho guardate, e ho detto a qualcuno che stava vicino a me, non so se a te o a mio padre, “Ma quelle sono le sorelle di Tanzi.” Quell’amico di mio marito e di mio cognato che era andato con loro quando loro avevano passato il fronte. Allora è successo qualcosa. Allora ho chiesto a questo, Otto dice lei, io pensavo un tenente ma insomma, ho chiesto a questo Otto di lasciarmi salutare quelle signore perché erano le mie cugine. Lui mi ha detto: “Sì, sì”. Ha fatto fermare il drappello perché eravamo, saremmo state dieci o dodici persone.
Mariuccia: Se non lo avessimo ammansito, non faceva una cosa così.
Rosetta: “Mi lasci salutare le mie cugine”, allora sono andata da loro e ho chiesto “Ma cosa è successo?” e dicono: “Siamo arrivate tardi, è stato il treno che non è partito al momento giusto, perché noi avremmo dovuto essere qui prima delle cinque, e invece il treno è arrivato in ritardo”. “Ma cosa è successo?” “Ma, Bruno e Paride sono scappati dalla Gestapo a Verona e Paride non sa dove sia andato a finire Bruno. Perché uno dei due si è sbagliato sull’accordo che avevano preso al momento” e allora dice “È venuto subito da noi a piedi da Verona e quando lui è arrivato noi siamo partite perché lui ha detto di andare ad avvisare tutti i Nulli, mia madre, mia cognata, che si nascondano, che scappino. E invece siamo arrivate tardi”. Così abbiamo saputo perché ci avevano prese.
D: Dopodiché, da Iseo, dove vi hanno condotte?
Rosetta: Da Iseo ci hanno condotte nelle celle sotterrane della Gestapo. Abbiamo fatto una breve fermata qui dove c’era il maresciallo Leo.
Mariuccia: Prima ci hanno portate nella sede del comune d’Iseo.
Rosetta: Sì, ma prima di andare.
Mariuccia: Questo non so perché. E mi ricordo che era giorno di mercato, c’erano le macchine, le Volkswagen tedesche in piazza, e non c’era nessuno in piazza. Tutta la gente era nascosta sotto i portici, ci hanno fatto fermare lì e noi abbiamo chiesto, sempre a questo capitano, se ci permetteva di andare a prendere qualche abito, perché era settembre, faceva ancora caldo, avevamo gli zoccoletti a casa, perché mio padre ha detto: “Qui sarà una faccenda lunga, cercate di portare qualche vestito”. Io e lei siamo andate a casa, che abitavamo poco lontano, abbiamo raccolto qualche straccio da metterci e siamo tornate lì in comune. Nel frattempo una delle mie zie è venuta a chiamare mia madre ed ha chiesto il permesso d’accompagnarla a salutare sua madre che era morente. È poi morta due ore dopo. Allora in mezzo a due col fucile…
Rosetta: Anch’io sono andata con la mamma.
Mariuccia: Sei andata anche tu? Io non mi ricordo.
Rosetta: Sì, con la mamma e penso sono andata io con Ennio.
Mariuccia: A salutare questa donna che stava morendo di polmonite.
Rosetta: Comunque lì dal municipio dopo siamo andate alla casa in paese, la nostra casa, di quando eravamo ragazze.
Mariuccia: Io e lei da sole.
Rosetta: Sì, siamo andate lì.
Mariuccia: Poi siamo andate a Brescia, dove c’era questo Leo che non sanno se è Leo o un altro, o si chiamasse in un altro modo.
Rosetta: Il quale si è comportato in un modo così, veramente, assurdo. Io non lo avevo mai visto. Siamo entrate, sono entrata io e tenevo per mano il bambino, poi è entrata dietro di me mia suocera e poi loro. Lui è andato lì vicino a mia suocera e ha chiesto: “Bonomelli?” E lei si è rivolta verso di me per dire: “Perché?” e pam! Le ha dato una sberla, te la ricordi?
Mariuccia: Sì.
Rosetta: Una sberla, ma proprio, e io ho reagito un po’, ho detto: “Ma cosa sta facendo, ma non ha fatto niente. Ma che cosa sta facendo?” “Ssst”, ha detto, “sedetevi tutti”.
Mariuccia: E ci hanno messi in una stanzetta. Ma io voglio tornare indietro a fare una considerazione, non so quanto valore possa avere. Che noi non eravamo degli illustri sconosciuti, diciamo, gente tranquilla che non si sa se esiste, perché mio padre era già stato arrestato una volta dai fascisti per attività partigiana, perché aiutava i partigiani ed organizzava anche un po’ la Resistenza della valle. Tant’è vero che mia sorella, che forniva i partigiani d’armi, era già in prigione a Brescia, qui, agli Spalti di San Marco, nel suo piccolo faceva qualcosa anche mia madre perché preparava i viveri, glieli faceva portare e la nostra casa era un po’ un viavai di gente di questo genere. Con questi precedenti e con la conoscenza precisa che avevano delle nostre opinioni nei loro riguardi, forse hanno preso ancora di più la palla al balzo per fare imbarcare tutta la famiglia, perché penso che se fossimo stati dei contadini tranquilli, che non avevano mai fatto niente, non si sarebbero neanche scomodati.
Rosetta: Veramente, lì nel campo di concentramento dove eravamo noi, c’erano tantissimi ostaggi, gente che era stata presa esclusivamente perché i loro figli erano andati ad arruolarsi o con i partigiani o con l’Esercito Italiano passando le linee, beh, comunque loro per venire a prenderci hanno scelto quel momento.
Mariuccia: Quella è stata senz’altro la causa determinante, ma anche in paese, noi non eravamo visti con grande giubilo, perché io le dico solo un particolare, per venire a prenderci in quel posto lì ci voleva uno che spiegava molto bene dove si doveva andare, e ripeto, se noi fossimo state persone ammanicate col potere o semplicemente persone tranquille, forse anche le autorità comunali di allora sarebbero state meno sollecite a dare una mano, questa è la mia opinione.
D: Mariuccia, quanti anni avevate voi allora?
Mariuccia: Io sono del ’22, allora avevo 22 anni.
D: E voi Rosetta?
Rosetta: Io sono del ’18, allora avevo 26 anni.
Mariuccia: Comunque dopo questo episodio mia sorella Agata, che era stata arrestata dai fascisti, ed era in prigione e aveva avuto il processo e la condanna a trent’anni per attività partigiana, è stata interrogata da Priebke e passata sotto la giurisdizione anche lei delle SS.
D: Era stata processata al Tribunale Speciale?
Rosetta: No, non era stata ancora, non lo hanno mai fatto il processo di Agata.
Mariuccia: Ma perché dici così?
Rosetta: No, non l’hanno mai fatto.
Mariuccia: L’hanno condannata a trent’anni, vuoi che la chiamiamo al telefono per domandarglielo?
Rosetta: Ma se diceva, coso, come si chiama quello là? Streparara.
Mariuccia: Quello che dice Streparara lascialo perdere, Streparara era un imbecille qualsiasi. Agata è stata condannata ad anni trenta di prigione.
D: Quindi vi hanno portate a Brescia?
Mariuccia: Sì, a Brescia
D: Nel comando delle SS?
Rosetta: Sì, al comando delle SS. Siamo state lì una mezz’ora, poi ci hanno ricaricato su due macchine e siamo andate alla Gestapo a Verona, il Palazzo dell’INA, in via di Porta Nuova, c’è tuttora. Lì sotto, nelle cantine avevano ricavato delle celle dove, se si staccava la rete dalla parete e si tirava giù, non ci si poteva più neanche muovere. Io ero in cella con il mio bambino, la Mariuccia era in cella con… no? Da sola? Mia suocera? Come dici, eri in cella con mia suocera? Tu?
Mariuccia: No, eravamo in cella uno per uno. Perché forse volevano che qualcuno di noi dicesse quel che sapeva, che poi non si sapeva niente.
Rosetta: Sì, assolutamente niente, e poi fra l’altro, questi agenti dell’Intelligence Force dell’8^ Armata Britannica avevano anche delle disposizioni, ed era questo: “Se voi siete presi od arrestati, voi dite esattamente come sta la situazione, cioè da dove partite, come siete organizzati perché”, dicevano, “è inutile fare gli eroi”. Loro intanto queste cose le sanno già benissimo. Voi diteglielo esattamente, tranquillamente. Quindi è per questo che è strano che loro continuassero a fare degli interrogatori anche a me, in quei due giorni che sono stata lì mi hanno chiamato non so quante volte per dirmi: “Ma lei lo sa dov’è suo marito?” “Ma cosa vuoi che sappia io dov’è mio marito” “Ma dove potrebbe nascondersi?” “Ma non lo so”.
D: Perché lui nel frattempo era scappato e non si sapeva dov’era? Voi non lo sapevate?
Rosetta: No, io l’ho saputo soltanto dopo che è finita la guerra.
D: Dopo questi due giorni di interrogatori, lì a Verona, cosa è successo?
Rosetta: Ci hanno caricato su una corriera insieme con altri detenuti che venivano da altre carceri di Verona.
Mariuccia: Ci hanno presi e messi sulla corriera. La corriera è partita e si è fermata alla prigione Degli Scalzi. Sono saliti venti o ventidue individui, tutti uomini, non so perché, qualcuno forse era lì proveniente ancora dal campo di Fossoli, qualcuno. Però, non so. Dopo di che siamo andati a Bolzano.
D: Ecco, ma vi avevano detto che vi avrebbero portati a Bolzano?
Mariuccia: Sì, perché la mattina, quando mi sono alzata e sono andata a lavarmi al bagno, alla fontanina, questo ufficiale, Tito? Quest’ufficiale che aveva presieduto tutti gli interrogatori e che insisteva con “Nicht rappresaglia, Nicht rappresaglia”, quello me lo ricordo molto bene, mi è venuto vicino e mi ha detto: “Niente buono campo di concentramento per donne e bambini, niente buono”
Rosetta: Sì, sì, l’ho sentito anch’io.
Mariuccia: Ma mi ha quasi fatto capire che lui avrebbe continuato ad interessarsi al nostro caso. Io non capivo perché, allora veramente non si capiva quasi niente di tutta questa storia. Perché, lei lo sa, forse non lo sa meglio di me, ma lo sa come me, che avvenivano arresti in tutti i modi strani. Avvenivano esecuzioni sommarie, a piacere, come era successo a suo suocero, avvenivano deportazioni di cui uno non si rendeva conto del perché venivano fatte, quindi uno accettava quello che gli capitava sulle spalle, in una specie di fatalismo, e con la speranza che non fosse poi così drammatica la cosa come si profilava. Comunque questa frase me la ricordo, “Niente buono campo di concentramento”. E io mi ricordo di aver pensato: “Sarà sempre meglio di una cella senza finestra”, ho pensato questo. Ignara del fatto che se questo Eisenstein non ci avesse fatto mettere il cartellino di ostaggi, ma si fosse incattivito e ci avesse fatto mettere quello dei prigionieri politici, noi partivamo per la Germania. Perché quando siamo entrati negli uffici del campo, dove ci ricevevano, c’erano lì parecchi tedeschi, e io allora non sapevo neanche chi erano. Ho l’impressione che questa situazione fosse stata voluta proprio dalla Gestapo di Verona. Perché la notte ci hanno messo nei blocchi delle celle, delle donne a Bolzano, e a notte alta, saranno state le undici, si è aperta la porta, i chiavistelli, è comparso questo Hans che io ho visto per la prima volta, e ha dato ordine, ci ha chiamato per numero, “Blocco celle” ha detto. Allora noi siamo scesi dai nostri panconi, che non ricordo più neanche se erano i terzi, i quinti, i terzi o i quarti, e gli siamo andati dietro. Siamo andati dietro a questo signore, ci ha aperto la porta delle celle appena costruite, ci ha messo in una cella tutti insieme.
D: Tutta la vostra famiglia?
Mariuccia: Tutta la famiglia. E c’era un mormorio, quello me lo ricordo, “Ma poverini, vanno nelle celle”, perché giorni prima, e qui lo vedo riportato, proprio da quelle celle lì erano stati portati fuori questi ventitré italiani che erano stati fucilati. Il giorno 12 settembre. E noi siamo arrivati il giorno 14, quindi le celle erano vuote, in una era rimasto il famoso capitano Barda, alias Enzo Sereni, e il giovane Vittorio Duca, figlio di quel Duca, non so il cognome, il nome proprio, che era stato ucciso.
Rosetta: Quando siamo andate noi alle celle c’era già il capitano Barda?
Mariuccia: Perbacco! C’era il capitano Barda, e Vittorio Duca, erano loro due in quella cella lì, dopo Vittorio Duca lo hanno passato capo blocco, nel blocco E, è andato via, ma è stato lì qualche giorno. Questo è quello che ricordo, molto esattamente.
D: Possiamo fare un pezzettino di passo indietro?
Mariuccia: Sì. Come vuole.
D: Da Verona siete partite in corriera?
Rosetta: Sì, con un pullman.
Mariuccia: Lei lo chiama pullman, era un autobus tutto sgangherato, bianco, era. Pullman di gran turismo!
D: Con il pullman e siete arrivate, c’eravate su voi, e poi quegli altri prigionieri che….
Rosetta: Eravamo circa una cinquantina, non voglio proprio ostinarmi sul numero preciso, ma mi sembra di aver contato e aver detto “Siamo in quarantasette”.
Mariuccia: Lì a Verona però eravamo saliti solo noi. Non ti ricordi? Che non c’era nessuno dalle celle di Verona che era salito.
Rosetta: Siamo saliti soltanto noi.
Mariuccia: Solo noi. Il pullman, il bus, chiamalo come vuoi, quella specie di carcassa bianca, ha girato per la città e si è fermato davanti alla prigione Degli Scalzi. Io, la prigione degli Scalzi la conoscevo attraverso don Chiot, quel famoso prete che confessava i condannati a morte e li comunicava, ed insieme all’ostia gli dava la sigaretta. È un personaggio famosissimo questo don Chiot, era noto perché in questa prigione lui aveva…
D: Com’è che faceva a nascondere?
Mariuccia: Questo è un fatto vero. Nascondeva la sigaretta in mano, in modo che i condannati andavano a fare la comunione e lui gli faceva scivolare la sigaretta da fumare, adesso non so in che modo, queste informazioni più precise le può prendere lì dalla procura di Verona o da associazioni partigiane di Verona. Mi ricordo che conoscevo la prigione Degli Scalzi attraverso quello che mi dicevano, già allora, attraverso le esperienze di quelli che sapevano, insomma. Per cui mi fece molto effetto questo portone, una casa antica, un portone in pietra, dentro si è spalancato e hanno fatto salire questa gente, in abiti civili. Si capiva che era gente che era lì da parecchio tempo, niente, questo mi ricordo.
D: E poi siete partite per Bolzano.
Mariuccia: Siamo partite per Bolzano.
Rosetta: Siamo andate a Bolzano.
D: Senza nessun altra fermata?
Mariuccia: Sì, a Rovereto ci siamo fermati. Abbiamo fatto una fermata a Rovereto, ci hanno fatti scendere dal pullman. Tutti. Per motivi anche igienici e lì ho saputo che avevano progettato la cattura, diciamo, delle guardie che c’erano sulla corriera. E la liberazione di tutti attraverso un colpo di mano, insomma, che non è stato attuato perché hanno visto che, mentre loro non se lo aspettavano, che c’erano delle donne ed un bambino, e per paura che nel conflitto, che ci sarebbe stato di sicuro, a fuoco, con i sorveglianti armati di mitra, succedesse, ci fossero delle vittime, donne e bambini, così siamo andati a Bolzano, dopo ci siamo fermati un’oretta.
D: Siete arrivati a Bolzano, più o meno a che ora? Ve lo ricordate?
Mariuccia: Io mi ricordo che erano verso le cinque di sera.
Rosetta: Sì.
D: E quando siete entrate in Via Resia vi hanno dato subito l’immatricolazione?
Mariuccia: Dunque, sì è spalancato questo cancello, siamo entrati con la corriera e ci hanno fatto scendere, poi qui io ho dei ricordi un po’…, mi ricordo che gli uomini li hanno portati da una parte e li hanno fatti rapare.
D: Subito?
Mariuccia: Penso subito, perché noi siamo entrate e non ci hanno rapato. Né me, né lei, né mio padre, perché come siamo entrati io ho visto subito questa gente con le tute blu, tutte rapate e mi ha fatto un effetto impressionante, proprio un’impressione, un colpo ho avuto nell’entrare, era un mondo diverso. Un mondo completamente diverso da quello a cui eravamo abituate, sia pure in mezzo alle vicende piuttosto drammatiche o complesse che si vedevano anche fuori dal Lager, se ne vedevano parecchie.
Rosetta: Ma mentre ancora eravamo nelle celle della Gestapo, lì a Verona, proprio la prima sera che siamo arrivati, io ero nella cella con Ennio, la cella si è aperta e c’erano due soldatesse tedesche ed una interprete. L’interprete mi ha detto che dovevo dare il bambino perché sarebbe stato portato in un posto più adatto, che non poteva stare lì. Allora io ho preso in braccio mio figlio e ho detto: “Ma no, sta qui, lo lasci qui.” “No, lo deve dare, deve lasciarlo andare”. Lui si era attaccato al mio collo, molto fortemente, però penso che senz’altro sarebbero riuscite a staccargli le braccia, non diceva niente e stringeva sempre di più, quella ho visto che si era veramente arrabbiata, e ha detto all’interprete di dirmi che se io non glielo davo lei me lo avrebbe strappato. In quel momento ho sentito i passi sulla scala a chiocciola ed è sceso un maresciallo che si chiamava Eisenstein.
Mariuccia: È quello che ci ha salvato, praticamente.
Rosetta: Quel maresciallo prussiano, dopo mi ha detto che era un maresciallo prussiano, ha detto a queste due di andarsene, mi ha detto: “Stare tranquilla, bambino insieme con lei”.
Mariuccia: E come, come lato umoristico le dirò che mio padre, mentre avveniva questa scena, che tutti definirebbero tragica, continuava a dire: “Te mologhe mai el gnaro”, cioè la incitava a non lasciarglielo. E forse senza questa insistenza, chi lo sa? Non sappiamo cosa sarebbe successo. Questa scena è durata, nel silenzio più totale, almeno dieci minuti.
Rosetta: Questo maresciallo mi ha detto, per la prima volta, perché poi me lo avrà ripetuto cento volte, mi ha detto: “Lei venire mio piccolo chalet Germania”, vero? “Lei e bambino, venire mio piccolo chalet in Germania”.
Mariuccia: Si vede che sperava di portarla fuori.
Rosetta: Sì, e allora io attribuivo questo al mio, non so, a qualcosa di non so, “Si vede che forse gli piaccio”, pensavo. E invece poi sono rimasta molto delusa, perché quando ho raccontato queste cose a mio marito, finita la guerra, lui mi ha detto: “Ah, il maresciallo prussiano, ma non lo sai che lavorava con gli inglesi?”
Mariuccia: Ma questo noi lo abbiamo immaginato, perché quando stavamo salendo tutti in fila, sul predellino della corriera, lui si è avvicinato a mio padre, ed in italiano ha detto: “Io questa sera mandare mio uomo a Firenze”. Noi eravamo tutti presi da questa vicenda, che ci portavano via, no? Al momento non ci abbiamo fatto caso, poi mio padre fa: “Ma a Firenze ci sono gli alleati”.
Rosetta: No, non c’erano ancora gli alleati. A Firenze gli alleati sono arrivati due o tre giorni prima di Natale.
Mariuccia: Beh, comunque “Io mandare mio uomo a Firenze” voleva dire che aveva dei contatti con gli alleati e che da Firenze qualcuno avrebbe… e allora lì abbiamo capito che c’era una situazione, che a noi sfuggiva, ma che era molto, molto più complessa di quanto si pensasse, ecco.
Rosetta: Sì, poi quella insistenza, “Venire mio piccolo chalet in Germania”.
Mariuccia: Questa qui “Stasera mandare mio uomo a Firenze” mio padre si è scervellato per tutto il viaggio. Comunque in settembre non erano ancora a Firenze, gli alleati.
D: Non me lo ricordo.
Rosetta: No, no, no.
Mariuccia: Nel settembre del ’44.
Rosetta: Roma è stata occupata nel giugno, il 20 giugno del 1944.
Mariuccia: Guarda che Roma è stata occupata nel ’43, Rosetta. È stato l’8 settembre.
Rosetta: Del ’44, è stata liberata nel ’44.
D: Liberata.
Rosetta: Roma è stata occupata dagli alleati il giugno 1944.
Mariuccia: Ah, sì, nel ’44.
Rosetta: L’8 settembre è stato nel ’43, allora c’erano gli italiani, e poi è stata occupata dai tedeschi.
D: Quindi l’ingresso di Via Resia, gli uomini sono stati messi, li hanno portati dall’altra parte.
Mariuccia: Non ho più guardato, confesso che non mi ricordo.
D: Il vostro gruppo, la vostra famiglia è rimasta tutta unita, diciamo.
Mariuccia: Sì.
D: L’immatricolazione ve l’hanno fatta subito?
Mariuccia: Subito, ci hanno dato il cartellino, io non mi ricordo però se mi hanno dato subito il cartellino. Questo non me lo ricordo.
Rosetta: Ma io credo che quando siamo arrivati la sera…
D: Neanche il numero?
Mariuccia: No, perché il cartellino ed il numero avevano, erano inscindibili. C’era il numero ed cartellino del colore X o Y. E probabilmente il cartellino ce l’hanno dato il giorno dopo. Perché se no non ci avrebbero messo nel blocco delle donne, se non c’era qualche cosa di…
Rosetta: Io mi ricordo che la prima notte che ho dormito a Bolzano avevo ancora il vestito che avevo quando ci hanno portati via.
Mariuccia: Sì. Il giorno dopo ci hanno dato…
Rosetta: Quindi quella sera lì loro a noi non ci hanno dato la tuta o altro, io non mi ricordo niente, mi ricordo però che sono venuti a prenderci al mattino e siamo andati al comando.
D: Il vostro babbo, è venuto anche lui con voi?
Mariuccia: Sì, quella notte lì, sì. Dopo lo hanno messo nella cella vicina, dove c’erano i cosiddetti prigionieri civili. Di nazionalità diversa, c’era lì uno di San Marino, per esempio, poi c’era un marocchino, poi c’era, ogni tanto, qualcheduno che stava lì magari due giorni, come Mike Bongiorno, che poi è andato via.
Rosetta: Io non l’ho visto.
D: A Bolzano, Mike Bongiorno?
Mariuccia: Sì, a Bolzano. E Mike Bongiorno è un illustre cafone. E adesso le spiego perché. Perché mio padre, che era un uomo molto aperto, aveva fatto amicizia con parecchie persone, tra le quali Virgilio Ferrari, alla liberazione lui, Virgilio Ferrari è diventato sindaco di Milano, e mio padre sindaco della liberazione ad Iseo.Allora lui gli ha scritto e si è congratulato, con questo dottor Virgilio Ferrari, e lui ha risposto. Come hanno fatto molti altri. Poi mio papà ha scritto anche a Mike Bongiorno, perché Mike Bongiorno aveva la dissenteria, ed i suoi compagni di cella lo aiutavano ad alzarsi e sedersi dal buiolo, ma dico, ma Mike Bongiorno non ha mai risposto, non ha detto: “Sì, mi ricordo che stavo male e mi avete aiutato”. Per dire la differenza tra le persone.
D: Poi vi hanno messo nel reparto celle, vi hanno fatto l’immatricolazione, vi hanno dato il triangolo, che era di che colore, il vostro?
Mariuccia: Verde.
D: Verde. Rosetta, il tuo numero te lo ricordi?
Rosetta: 4131.
D: Anche ad Ennio hanno dato un numero?
Rosetta: Sì, 4132.
Mariuccia: I triangoli sono questi. Quelli che sono riuscita a salvare.
Rosetta: Io avevo il 4131 ed Ennio il 4132, ecco.
D: Dove li mettevate questi?
Rosetta: Questi erano attaccati sulla tuta, sulla tuta blu con la croce di pittura ad olio dietro, così che da dietro era proprio come se si fosse in una specie di piccola corazza, perché resistesse ne avevano dato una quantità enorme.
D: Quindi vi hanno dato anche delle tute dopo, allora?
Rosetta: Sì, ci hanno dato una tuta e ci hanno portato via tutti gli abiti, abbiamo dovuto darli a loro gli abiti che avevamo, nostri, …
D: Tutto vi hanno portato via?
Rosetta: Sì, ci hanno portato via gli abiti, e…
Mariuccia: No, gli abiti non ce li hanno portati via.
Rosetta: Ma certamente Mariuccia, dopo io ti spiego.
Mariuccia: Io avevo il cappotto.
Rosetta: Dopo hanno dato qualcosa al bambino e poi hanno anche permesso che l’amico di mio padre portasse la roba che hanno mandato da Iseo al bambino perché il bambino non aveva una cosettina pesante, niente.
D: Quindi nella vostra cella c’era solamente la vostra famiglia? I componenti della vostra famiglia?
Rosetta: Sì, della nostra famiglia, eravamo in sei.
D: E tutto il giorno, cosa facevate lì a Bolzano?
Rosetta: Beh, i primi giorni, non so, non abbiamo fatto niente. Comunque io avevo chiesto alla Margherita, che era la prima moglie di Montanelli, una bella signora austriaca, che era incaricata di formare i gruppi di donne che andavano a lavorare. L’avevo pregata di mettermi negli elenchi perché lì non avrei saputo che cosa fare. E invece quando lei ha portato questo elenco al comando, il mio nome è stato cancellato. Hanno detto che io non potevo uscire a lavorare. Dovevo stare nel campo.
Mariuccia: Nessuno di noi poteva fare niente. Né io, né lei, né la signora Bonomelli, nessuno.
D: Quindi stavate nel campo tutto il giorno?
Rosetta: Sì, noi stavamo nel campo tutto il giorno, qualche volta…
D: Cioè, ma non tutto il giorno in cella?
Rosetta: No, potevamo… sì, ma non erano molto contenti se ci vedevano in giro. Noi ci andavamo, però stavamo un po’ attenti che in quei momenti non ci fossero vicino delle guardie.
Mariuccia: Guardi, nella prima cella c’era il capo campo.
Rosetta: Sì, nella prima cella c’era il capo campo.
Mariuccia: Ed il comandante Baccigaluppo della marina militare.
Rosetta: Ma dopo è andato via il comandante Baccigaluppo.
Mariuccia: È andato via dopo che sono andata via io, perché è sempre stato lì.
Rosetta: Ah, no, no, quando…
Mariuccia: Comunque era per spiegarle una cosa. Siccome lì c’era la sede del capo campo, aveva il diritto d’andare e venire a dirigere il campo, quindi il portone che dava sul cortile del Lager era sempre aperto di giorno. Veniva chiuso a chiave di notte. Come chiudevano a chiave di notte tutte le celle, ecco. Qualche volta non le chiudevano, ma per una pura negligenza, così qualche volta non la chiudevano. Ma nel novanta per cento dei casi chiudevano a chiave e si stava chiusi dentro. Fino a sera, si poteva anche parlare tra noi. Non so, c’erano dei giorni in cui chiudevano presto, degli altri in cui addirittura non chiudevano, questo non saprei dirle da che cosa…
D: Voi contatti però con gli altri deportati ne avete avuti?
Mariuccia: Moltissimi.
Rosetta: Sì, molti. Ma non con tutti insomma.
Mariuccia: Noi per esempio non potevamo mai andare, non avremmo potuto andare nei blocchi. Non ci siamo mai neanche azzardati ad andare nei blocchi degli uomini o nei blocchi delle donne. Io personalmente sapevo che era una cosa che non si poteva fare, ecco.
Rosetta: No, io sono andata due o tre volte nel blocco delle donne.
Mariuccia: Sì, ci sarai andata due o tre volte in sei, sette mesi, capirai.
Rosetta: Sì, sì, perché c’era uno lì, un nostro amico che lavorava nel reparto dell’elettricità e si era ammalato.
D: Lì a Bolzano?
Rosetta: Sì, lì a Bolzano. Ho visto, si chiamava Chiesa Federico. Era di Torino e la dottoressa Buffalini che era di Torino aveva mandato a chiamarmi e mi aveva detto: “Vai a trovare Chiesa che è ammalato, ha la febbre.” Allora io l’ho detto ad Hans, e lui mi ha permesso d’andare due minuti, mi ha detto: “Ti lascio andare due minuti, fai alla svelta”. Poi ci sono andata ancora altre volte, ma certo per pochi minuti perché non…
Mariuccia: Ecco, Pietro San, ecco un altro che mi ricordo. Me lo scrivo.
Rosetta: L’episodio bello che ricordo, non bello, insomma un episodio curioso, è la storia di mio figlio ed il fischietto. Un pomeriggio ho portato a spasso mio figlio intorno al campo.
D: Ma dentro al campo?
Rosetta: Sì, sì, dentro. Dentro. Poi quando stiamo per entrare nel corridoio delle celle, lui mi sfugge di mano e si mette a correre. “Fermati!” dico io, “Ma dove vai? Fermati! Guarda che adesso devi andare dentro, è tardi, fa freddo”. Lui invece d’ascoltarmi, continua a correre. Io sto un attimo a guardarlo e penso: “Beh, ritornerà. Farà il giro intorno all’edificio e poi verrà su dall’altro cortile dove fanno le adunate.” Nello stesso tempo sento un suono di fischietto, che era il suono classico che facevano le guardie quando c’era un’adunata. “Pfiii”, e poi dopo un momento, “Pfiii”, allora dico: “Ma Dio, quel bambino mi è scappato e adesso fischiano anche per un’adunata, bisogna che io vada a vedere che cosa è successo”.Intanto cominciavano ad uscire quelli che, non erano ancora tornati dal lavoro, ma quelli che lavoravano vicino, alcuni sono rientrati per dire: “Cosa succede? Sentiamo il fischio”. Insomma, si era fatta una bella folla di gente. Finalmente io sono riuscita ad acchiappare mio figlio, era lui che fischiava. Allora lì erano intervenute anche alcune guardie perché non capivano neppure loro che cosa stesse succedendo, allora io lo prendo e dico: “Dammi quel fischietto, ma che cosa ti viene in mente, ma hai visto che cosa hai fatto? Ma non sai adesso che cosa succederà? Vieni, andiamo nelle celle.” Allora lui si era reso conto che la cosa era veramente …, andiamo nella cella ed io dico: “Dammi il fischietto” “Non ce l’ho più” e faceva così con le mani. “Ma dove lo hai buttato?” “Non ce l’ho più”. Dopo dieci minuti è arrivato il maresciallo Haage con altri due tedeschi a volere il fischietto. Lui diceva “Non ce l’ho più. Non ce l’ho più”. Allora il maresciallo Haage è uscito ed ha ordinato di chiudere la cella. Te lo ricordi? Mio figlio si è messo ad urlare come un matto, “Scheisse, los”.
D: Era l’unico bimbo che c’era nel campo, di quell’età lì?
Rosetta: Sì, era l’unico bambino, penso che non erano molti i bambini ariani internati di quattro anni.
D: Ma quando siete arrivati voi, altri bambini non c’erano?
Rosetta: Sono passati alcuni, erano tutte bambine o bambini, quegli ebrei? Erano tre bambine.
Mariuccia: Sono state messe nella cella di fronte alla nostra con la mamma. Poi sono partite. Sono indicate anche nel libro che avete fatto voi. Le ho trovate indicate.
D: Quindi era l’unico bambino che c’era?
Rosetta: Era l’unico bambino, sì. E lì un accademico di Francia ha scritto per lui quella famosa poesia.
D: Un accademico di Francia che era deportato anche lui?
Rosetta: Sì, era un ebreo. Sì.
D: E ha dedicato questa poesia a Ennio?
Rosetta: Sì, carina, in francese logicamente.
D: Beh, certo.
Rosetta: Molto carina. Dopo la guerra siamo andate a cercarlo a Parigi.
D: E che cos’era quella riflessione lì, Mariuccia?
Mariuccia: Modestissima riflessione, dell’influenza che ha l’ambiente sulle persone, sui bambini. Mio nipote, che non aveva ancora cinque anni, s’era fatto, come modello, la figura del capo campo del Lager. Aveva voluto la fascia di capo campo ed era riuscito persino a rubare un fischietto per comandare le adunate, eccetera. Quello era il modello che lui aveva sotto gli occhi, il potere massimo che gli si presentava. Il massimo della felicità. Il capo campo oltre tutto andava fuori, faceva tutto quello che voleva ma soprattutto comandava, in quel luogo comandava.
D: Voi però dovevate comunque partecipare agli appelli?
Mariuccia: Noi non partecipavamo, a noi era proibito qualsiasi movimento che non fosse magari quello delle celle, a venti metri dalle celle. Tanto noi ci andavamo lo stesso, sa com’è? Si è anche un po’ incoscienti, e guardi, mio padre ha corso anche dei rischi, perché si affrettava sempre quando c’erano le partenze per farsi dare indirizzi, nomi, cose da scrivere alle famiglie. Si dava da fare in questo modo, tant’è vero che il maresciallo Haage lo ha picchiato per questo. Lo ha picchiato, gli ha dato due ceffoni perché aveva in mano un notes e scriveva quello che poteva, come poteva aiutare insomma, questi poveri disgraziati, lo faceva rischiando anche di suo. Rischiando la sua incolumità, perché lì non scherzavano, eh? Io sono sempre del parere che noi abbiamo evitato molti guai perché eravamo dei prigionieri speciali. La mia impressione è che noi fossimo un granellino dentro un ingranaggio bellico che era mille volte più grande di noi. Perché questo maresciallo Eisenstein che mandava il suo uomo a Firenze, forse si serviva di noi e ci proteggeva per avere in contro parte qualche cosa da parte degli alleati. Lei sa molto bene che il generale Wolff stava trattando la resa delle SS in Italia, no? All’insaputa di Hitler. Quindi si vede, nel patto tra gli alleati e le SS c’era anche quello di non fare rappresaglie e anzi di cessare le rappresaglie e magari di far vedere la buona volontà anche del corpo delle SS d’aiutare quelli che potevano essere aiutati. Questa è una cosa garantita, guardi. Ha visto poi l’articolo su Priebke? Dove c’è scritto che il tribunale aveva condannato mia sorella a trent’anni? Lo ha letto? Mi scusi. (Legge): Dopo quell’interrogatorio Agata Nulli non vide più Erich Priebke, dell’interrogatorio si parla sopra, ma il capitano delle SS si interessò ancora di lei, ed il 22 marzo 1945, poche settimane prima della liberazione, l’Hauptsturmführer scrisse dalla sede delle Gestapo di Brescia, in via Panoramica 10 al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di Bergamo. La Nulli, diceva la missiva di Priebke scritta in tedesco, è confessa d’aver favorito i ribelli con alimenti e sigarette; inoltre ha distribuito foglietti caduti da aeroplani, il procedimento è stato trasmesso dalla Guardia Nazionale Repubblicana al Tribunale per il giudizio. Prego di comunicare, chiedeva Priebke, se la Nulli è stata processata ed a quale pena è stata condannata. Il tribunale le aveva inflitto trent’anni di carcere per favoreggiamento nei riguardi dei partigiani. A questa richiesta di Priebke il tribunale ha ufficialmente risposto che aveva avuto trent’anni di carcere per favoreggiamento dei partigiani. Quindi lei è stata processata e condannata a trent’anni, come appare da questa corrispondenza tra Priebke, che non è l’ultimo arrivato, e il tribunale di Bergamo. Quindi non mi pare una cosa da poco, però se noi fossimo state delle persone totalmente fuori dal gioco, avrebbero aspettato tre giorni a venire a prenderci, ecco. Per far dire che non eravamo totalmente fuori dal gioco, ho fatto presente che il papà era già stato arrestato dai fascisti, tu lo sai molto bene, in agosto, e l’Agata era già stata arrestata, era già a Brescia.
D: Però vostra sorella non è venuta nel campo?
Mariuccia: No, lei è sempre stata qui.
D: È sempre stata nelle carceri qui?
Mariuccia: Sì.
Rosetta: Sì.
Mariuccia: Loro hanno detto: “Prendiamoli tutti, così non c’è più nessuno fuori, non so”. Loro sono venuti ad arrestarci per quel fatto lì. È chiaro, poi ho anche aggiunto che siccome arrivare a quel posto lì non è tanto facile, le autorità comunali fasciste d’Iseo, hanno dato una mano. Se noi fossimo state persone qualsiasi, forse non s’interessavano neanche.
Rosetta: Probabilmente loro erano venuti per arrestare la moglie di Bonomelli ed il figlio, a prendere la moglie di Bonomelli ed il figlio di Bonomelli, siccome c’era lì dell’altra gente avranno detto: “Meglio che li portiamo via tutti, che sarà una cosa…”
Mariuccia: Sì, a me se mi lasciava a casa non mi faceva nessun dispetto.
Rosetta: Eh?
Mariuccia: Io non ci tengo ad avere titoli di martirio e d’eroismo, proprio non ci ho mai tenuto.
D: Ma dentro al campo, quando spiegavi che il babbo metteva in atto questa forma di solidarietà.
Mariuccia: Sì, poverino. Ma non ha letto le lettere di quei due ebrei sopravvissuti? Di quell’ebreo sopravvissuto? Quella è una testimonianza inequivocabile che quello che poteva fare là, lo faceva.
D: Avete trovato o conosciuto altre persone dentro nel campo?
Mariuccia: Madonna, io ne ho conosciute tantissime, di cui ho solo i nomi, ormai.
D: Tipo?
Mariuccia: Ma uno è questo Gurtler, poi l’elenco l’avevo dato alla signora, adesso l’ho lasciato a casa.
D: Ma così, a memoria?
Mariuccia: Mi ricordo Elmo Spreafico, quel Chiesa lì, Vittorio Duca, Ermando Sacchetta, tanti, guardi in questo momento mi sfuggono.
D: Con Vittorio Duca avevate stabilito un…
Mariuccia: Un vero rapporto di grande amicizia.
D: Che alla fine poi lui, che cosa ha fatto, vi ha dato?
Mariuccia: Io sono uscita prima, a lei ha dato, quando l’hanno mandata in Germania … e poi Vittorio Sereni, abbiamo conosciuto. Il capo comandante Baccigaluppo. I due fratelli Momigliano, Attilio ed Emilio Momigliano.
Rosetta: Vittorio Duca è arrivato, l’ultima partenza, perché dopo non è più partito nessuno.
Mariuccia: Altre persone di cui non ho conosciuto il nome ma che erano evidentemente persone di un’evidenza notevole, insomma persone di grande valore, professori universitari, studiosi, poi i nomi non me li ricordo più.
Rosetta: Abbiamo conosciuto don Gaggero, un prete di Bergamo, quello grande e magro.
Mariuccia: Don Vismara, don Berselli. Poi quando avevano ucciso il sig. Bonomelli, mio padre si è dato molto da fare, perché loro, i tedeschi, lo volevano seppellire nell’orto, lui è intervenuto e lo ha impedito.
D: Ma lì a Bolzano?
Mariuccia: No, qui a casa di mia sorella. Questo era antecedente.
D: Ecco Mariuccia, padre Gaggero, lui usciva dal campo?
Mariuccia: Andava a lavorare. Dopo io mi ricordo che ho scritto che non ero a conoscenza di un’attività clandestina d’aiuto ai deportati, non ero a conoscenza. Però so, da alcune vicende di don Gaggero, che lui era in contatto con qualcuno fuori che gli dava dei soldi e delle cose, per cui pigliava sempre, aveva preso un sacco di botte, era stato ridotto una palla, perché volevano fargli dire chi era che gli dava queste cose. E lui non lo ha mai detto. Io ricordo che ero molto ammirata dal suo comportamento, che passava, dopo lo hanno chiuso in cella, e lo facevano uscire e passava nel campo, io dallo spioncino lo vedevo passare con la faccia tutta livida e tutto zoppicante perché effettivamente era stato molto picchiato per quel motivo lì. Non saprei dirle altro perché non era molto opportuno andargli a parlare ad un certo punto.
D: Quindi c’erano anche sacerdoti dentro nel Lager?
Mariuccia: Eh, sì. Poi è entrato in prigione anche il parroco di Bolzano, che era quello che si diceva, si sapeva, che portava, non so se desse dei viveri o avesse dei contatti d’altro genere, o del denaro, non so. Non saprei. E io ricordo che mio papà rideva, perché diceva: “Tu vedrai, me lo diceva in dialetto, vedrai quanto tempo passerà prima che entri dentro anche quell’altro prete che gli dà i soldi”. Perché poi le cose si sapevano, in maniera trasversale, come dicono, si sapeva che don Gaggero usciva a lavorare, che c’era un prete che gli dava dei soldi da dare ai prigionieri, e si sapeva che anche quello là un bel giorno sarebbe entrato dentro, e difatti così è stato. Non so altro perché poi, ripeto con don Gaggero quando era in cella e veniva fuori a fare la passeggiata, non si poteva parlare.
Rosetta: Io don Gaggero l’ho visto dopo. A Genova. Apparteneva ad un ordine sacerdotale.
D: Erano i Filippini di Genova.
Rosetta: Erano i Filippini di Genova, ecco, io sono andata alla chiesa di San Lorenzo a Genova e l’ho incontrato.
D: Sì, ha anche subito un processo.
Mariuccia: E’ uscito dalla Chiesa, diciamo ufficiale, ed ha fondato un movimento che allora ha avuto anche molto seguito. Poi è scomparso.
D: Sì, sì, era stato a Praga, eh, ma è stato per due anni poi a Roma perché il Sant’Uffizio lo aveva processato.
Mariuccia: Sì, sì, ma era un tipo molto originale, non era un uomo comune.
D: Mi sembra che era anche vivace.
Mariuccia: Io lo avevo notato come una personalità spiccatissima e diversa da tutte. Forse era la personalità che mi ha colpito di più di tutti gli uomini che ho conosciuto nel campo.
D: Rosetta? Ah, no, sta prendendo un appunto. Se no si dimentica.
Rosetta: No, no. Mi dica.
D: Quindi avete conosciuto queste persone qui, contatti quindi all’interno del campo però, all’interno del Lager di Via Resia, c’era un movimento diciamo così, resistenziale? C’erano delle persone che si davano da fare, che aiutavano gli altri?
Mariuccia: Ah, questo sì.
Rosetta: Ma aiutavano in che senso?
D: In tutti i modi, magari anche conforto, perché stare in un Lager non penso che sia la cosa più bella di questo mondo. Cioè essere privati della propria personalità, per esempio, il fatto di non essere più una persona ma di essere un numero.
Rosetta: Io le dico sinceramente che ho assistito a certe scene di litigi proprio per delle cose, delle cattiverie.
Mariuccia: Beh, questo sì.
Rosetta: Di cose veramente, che mi sembrava che il senso della solidarietà non fosse per niente diffuso, ecco.
D: Ah, no?
Rosetta: No, no.
D: Cioè?
Rosetta: Sì, se uno aveva un pezzettino di pane e vedeva un altro in parte che stava crepando di fame, sarebbe stato molto difficile, perché comunque noi abbiamo vissuto un po’ fuori da quei giorni lì.
Mariuccia: Però le dirò anche che gli spazzini per esempio, che ad un certo punto erano quasi sempre ebrei, e ad un certo punto i capo cessi che erano i due fratelli Momigliano, desideravano ardentemente tutti di venire a fare gli spazzini nel nostro corridoio perché lì beccavano qualche cosa, gli si dava qualche cosa di quello che avanzava a noi o un goccio di caffè, poi se avevano bisogno d’aggiustare le mutande o qualche cosa di simile, la mia mamma, la signora Lina, si faceva quello che si poteva, insomma.
Rosetta: Anche la sottoscritta.
Mariuccia: Noi facevano quello che potevamo, potevamo fare molto poco, ma…
D: Lì c’era una donna?
Rosetta: Una iena, la chiamavamo la iena.
Mariuccia: E la Marge, dov’era la Marge? Io ho segnato nei miei appunti una certa Marge.
D: La iena? C’era la iena, la Tigre lì, no? E poi c’era anche un’italiana, piccolina, che era un capo baracca.
Rosetta: La capo blocco? Beh, ma la capo blocco era un’internata italiana.
Mariuccia: Io non me la ricordo.
D: No?
Rosetta: Anch’io non me la ricordo molto, io ricordo molto la Montanelli, perché ci s’incontrava.
Mariuccia: Sì, quella piccolina, ha ragione.
Rosetta: Quella piccolina.
Mariuccia: Mi farò venire dalla nebbia della memoria qualche …
D: Cicci, si chiamava.
Mariuccia e Rosetta: Ah, la Cicci, la Cicci.
Rosetta: Ma c’è ancora? Vive ancora?
D: Ed ha sposato il capo campo maschile.
Mariuccia: E chi era, Maltagliati?
D: No, Gigi Novello.
Rosetta: Ah, il Gigi Novello.
Mariuccia: Anche quel Novello lì me lo ricordo, io.
Rosetta: Gigi Novello, ah, è un amore che è sorto nel Lager?
D: A San Vittore, prima del Lager.
Mariuccia: Eh, ma Gigi Novello ha fatto il capo campo per pochissimo, io non l’ho mai visto capo campo, il Gigi.
Rosetta: Comunque, ma lei sa che da lì, dal Polizei Durchgangslager di Bozen, alla metà di marzo, sono state portate via diciannove donne perché erano incinta di quattro mesi?
Mariuccia: Robe da pazzi.
D: No, questa cosa non…
Rosetta: Questo mi ricordo, dunque li troverò, perché quel coso di appunti…
Mariuccia: Che fine abbiano fatto non si sa.
Rosetta: Hanno detto che le portavano in un ospedale a Merano.
D: Più o meno, il periodo quand’era, Rosetta? Quando è avvenuto, questo?
Rosetta: Questo deve essere avvenuto, era ancora marzo, deve essere stato, non so, poco prima o poco dopo la metà di marzo. A me hanno detto che erano in diciannove, facciamo anche fossero nove, però questo è veramente successo, io ne conoscevo tre o quattro di donne incinte ed una era la figlia di quella di Vicenza, ti ricordi quella signora anziana di Vicenza che era dentro con la figlia, anche loro come ostaggi?
Mariuccia: No. E quella di Piacenza, come si chiamava quella di Piacenza zoppa?
Rosetta: Ah, quella di Piacenza zoppa.
Mariuccia: Era un personaggio, che poi ha fatto carriera nel Partito Comunista.
Rosetta: Ma non avevate mai sentito questo, che c’erano le donne incinte?
D: No.
Rosetta: No, no, guardi, glielo assicuro proprio.
D: Non si sa che fine abbiano fatto?
Rosetta: Io so che queste donne sono uscite, hanno detto che sarebbero andate all’ospedale, ecco. E poi un giorno sono state portate all’ospedale, mi sembra perfino ai primi di marzo? Perché insomma faceva ancora freddo, qualcuna non stava bene, e così, dopo, di due sono sicura, perché me lo hanno detto loro che erano incinte e sono andate, una era questa, mi verrà in mente il nome del paese, lì delle vicinanze…
D: Voi vi ricordate un trasporto che dal campo sono partiti con un camion?
Mariuccia: Beh, ma partivano sempre con il camion.
D: Ah, sempre con il camion?
Mariuccia: Io li ho sempre visti con i camion.
Rosetta: Perché li portavano alla stazione poi quelli che partivano, no?
D: Ecco, lì invece dovevano partire con il trasporto della stazione, poi invece Pippo aveva bombardato, e allora lì non hanno fatto più il treno, e c’è questo camion con su delle persone, portate ammanettate e non si sa più che fine abbia fatto questo camion. E c’era anche un sacerdote su questo camion, che era anche lui claudicante, aveva una malformazione ad una…
Mariuccia: Un sacerdote?
D: Un sacerdote di Padova era.
Mariuccia: Non si ricorda il nome?
D: Sì, me lo ricordo sì.
Mariuccia: Il nome?
D: Don Placido, si chiamava.
Rosetta: Io non mi ricordo.
Mariuccia: E si ricorda in che data?
D: Lui è stato preso a Padova.
Mariuccia: In che data è stato questo camion? Perché noi vedevamo i camion partire, poi dopo non si sapeva se partivano o non partivano per la Germania.
D: Don Gian Antonio Cortese, si chiamava.
Mariuccia: Si sapeva solo che non erano partiti quando era interrotta la linea ferroviaria, dopo dove andassero i camion, perché tornavano indietro, … nel campo.
Rosetta: Questo senz’altro lo saprete anche voi, che poi lì in quel campo lì, verso la metà di marzo, non era più partito nessuno, eravamo dentro in 3.250, perché neppure con i camion potevano partire.
Mariuccia: Non potevano più partire.
Rosetta: La linea ferroviaria era interrotta, ed andare in giro con i camion così con su i prigionieri era pericoloso, eh?
Mariuccia: C’era un sacerdote zoppo, quello me lo ricordo io. Piccolo di statura.
D: Mariuccia, cos’è un Lager?
Mariuccia: Ah, santo cielo, mi fa una domanda molto difficile, perché il Lager comunemente è un posto dove uno va, chiuso dentro in mezzo al … non è più una persona, è un oggetto a disposizione di qualche d’uno d’altro, però soprattutto per me un Lager è una prigione psicologica, è l’annullamento della personalità, la privazione dei propri diritti, non dico i diritti del vivere, del mangiare, del dormire, ma dei diritti di essere se stessi. E di vedere gli altri essere persone.
D: Per una donna un Lager cos’è? Cos’è stato per una donna un Lager?
Mariuccia: Per me il Lager è la negazione della vita, siccome io la vita l’intendo non solo in senso materiale, prima di tutto è la negazione della vita in senso materiale e poi la negazione della vita in senso spirituale, totale proprio, e questa è la cosa secondo me più terribile, è quella dalla quale dobbiamo guardarci molto di più che da tutte le privazioni di tipo materiale. Sa poi, involontariamente si fa della retorica quando si parla di queste cose, perché sono argomenti pesanti, se uno non usa parole pesanti forse non viene neanche capito. E poi per me il Lager è anche una forma d’interiorità deviata. Mancanza d’amore della verità, mancanza d’amore della libertà, mancanza di consapevolezza, tutte queste cose, che ci possono non essere prima e succedere dopo, cioè venire dopo. Comunque il Lager è una cosa orrenda, diciamo. È proprio l’ombra del buio, come avete scritto voi nel vostro libro.
D: Vi ricordate in aprile la celebrazione della messa per la Pasqua, nel Lager?
Mariuccia: Io mi ricordo la celebrazione della messa, che si faceva sotto le ultime celle in fondo, nella vostra piantina sono ben indicate.
Rosetta: Sì, qualche volta hanno celebrato la messa.
Mariuccia: E mi ricordo, me lo ricordo perché ho scritto una lettera, nella quale descrivo questa celebrazione della messa, che è avvenuta così, noi eravamo andate là e c’era parecchia gente, perché la celebrazione della messa anche per uno che non è credente, in un Lager acquista un significato, un significato come dire di contatto umano fuori dalla prigione, fuori dall’imposizione, fuori dalla consuetudine negativa che ti comporta l’essere nel Lager. Eravamo in tanti, avevamo deciso di cantare, di cantare la messa. E invece nessuno è riuscito a cantare la messa perché si è visto come una specie d’emozione inibitrice che ha impedito alla gente, era poi la prima che si faceva, di cantata, poi le altre messe non le abbiamo cantate perché in quelle celle mettevano i prigionieri che poi venivano picchiati o torturati e molto spesso c’erano dei lamenti e delle urla che non facevano sentire neanche la celebrazione.
D: Come si chiamava il prete celebrante?
Mariuccia: Io non mi ricordo, me lo aveva detto lei, veniva da fuori, mi pare. Si chiamava Piola.
Rosetta: Lei ha chiesto della messa che hanno celebrato in aprile?
D: A Pasqua del ’45, c’è stata una funzione religiosa, sulla piazza dell’appello.
Mariuccia: La Pasqua, l’aprile del ’45? Io non c’ero.
Rosetta: Sì.
D: Vi ricordate?
Rosetta: Sì, me la ricordo. Sì, avevano fatto un altare che voltava, il celebrante voltava le spalle alle celle.
Mariuccia: Allora il rito era così.
Rosetta: Poi i particolari, ricordo vagamente.
D: Come facevate a sapere le informazioni dall’esterno, voi eravate al corrente d’informazioni dall’esterno?
Mariuccia e Rosetta: Sì, le chiedevamo a quelli che uscivano a lavorare.
D: E poi c’era, non so, una stampa clandestina dentro?
Mariuccia e Rosetta: Io non l’ho mai vista.
Mariuccia: Guardi, secondo me il motivo è che quello non era un Lager dove la gente si fermava, cioè era impossibile organizzare qualche cosa di consolidato, perché andavano e venivano, c’erano le partenze, e quando ormai non c’erano le partenze c’era una tale confusione di persone, ed anche un numero così eccessivo di persone che era impossibile insomma, secondo me, organizzare una cosa d’informazioni. Noi avevamo i nostri informatori privati, per esempio i falegnami, sapevamo quando c’era qualche morto perché venivano da mio papà e dicevano: signor Nulli, oggi abbiamo fatto cinque casse.
Rosetta: Palmiro, un falegname milanese, si chiamava Palmiro.
Mariuccia: Palmiro?
Rosetta: Sì.
Mariuccia: E veniva da mio padre e diceva “Signor Nulli, oggi cinque casse”. “Oggi tre casse”. Per questo che sappiamo che c’erano state o delle esecuzioni o delle morti naturali.
D: Ah, ecco, morti naturali, no, però?
Rosetta: No, ce ne sono state.
D: Anche morti naturali?
Mariuccia: Anche morti naturali, però.
Rosetta: Le due ebree delle celle che sono state fatte morire.
Mariuccia: Beh, ma quella non era una morte naturale, quella è stata un’esecuzione.
Rosetta: No, sono morte di broncopolmonite.
Mariuccia: Sì, va beh. Però ci sono state anche delle morti naturali, secondo me, gente vecchia, io non lo so, penso che ci fossero state, però le notizie delle casse si riferivano sempre a qualche prigioniero scomodo o che aveva dato dei problemi o che era lì per essere eliminato. C’erano perché mio padre, un giorno sì e un giorno no, riceveva la notizia dai falegnami che avevano fatto le casse. Sono sicurissima.
Rosetta: Ma questo d’un giorno sì e un giorno no, mi sembra un po’ esagerato.
Mariuccia: Loro venivano a dare le notizie, dopo fosse un giorno sì e uno no, o una settimana, non mi ricordo, so che venivano lì perché avevano confidenza.
Rosetta: E si vedevano anche le casse che uscivano fuori dalle celle, erano delle casse fatte di legno, una specie d’assi, ma non una parete completa, erano delle listarelle larghe, alte quattordici centimetri, e si vedevano, le portavano fuori dal Lager.
Mariuccia: Allora i falegnami le fabbricavano, dopo io non so dove andavano a seppellire queste gente.
Rosetta: E si vedevano, le portavano fuori dal Lager.
D: Dicevo questo perché, ad esempio in alcuni Lager abbiamo sentito che avevano organizzato per esempio Radio Scarpa no? Riuscivano a mettersi in contatto con la radio, avevano fatto una radio a galena, eccetera, a Bolzano questo non era successo?
Mariuccia: Io dico che il motivo è semplicemente questo, ed è anche più serio per il fatto che lì c’erano personalità della Resistenza che non rivelavano la loro vera identità, ed è giusto, quindi non si sarebbero di sicuro compromessi ad organizzare una Resistenza in un Lager; una Resistenza, diciamo un servizio di formazione, la chiami come vuole, gente che era già in bilico, che non voleva essere riconosciuta.
Rosetta: E poi al mattino quando uscivano queste squadre di lavoro guardi che il Lager si svuotava completamente, eh?
Mariuccia: Andavano tutti a lavorare.
Rosetta: Andavano fuori a lavorare nelle gallerie per fabbricare le bombe degli aerei, oppure le …
Mariuccia: Non so cosa facessero, facevano le traversine delle ferrovie.
Rosetta: Ed anche bombe, c’erano delle gallerie dove si facevano delle munizioni di vario genere, bombe a mano, questo lo dicevano quelli che andavano a lavorare, e quindi dalla mattina, perché poi a questi, a mezzogiorno, il rancio glielo portavano sui posti di lavoro. Alcune volte, in casi eccezionali, ma forse se c’era, non so, ogni tanto facevano un’adunata per qualche comunicazione, ma deve essere successo pochissime volte, comunque questa gente partiva alla mattina alle sei e mezza, sette e dopo ritornava alle quattro e mezza.
Mariuccia: Quello che non ricordo è se andavano a lavorare anche nei giorni in cui c’erano le partenze per la Germania. Quello non me lo ricordo.
Rosetta: No, nei giorni in cui c’erano le partenza per la Germania, non usciva nessuno.
D: Con che frequenza venivano fatte queste partenze per la Germania?
Mariuccia: Ah, io dico ogni quindici giorni, inizialmente.
Rosetta: Dieci, quindici giorni.
D: Cosa succedeva? Chiamavano i numeri?
Rosetta: Adunavano tutti e poi chiamavano.
Mariuccia: E poi al controllo, io non so come facevo ad essere lì, io ho visto come facevano ad organizzare la partenza. Loro facevano, schieravano tutti i prigionieri nel recinto, davanti al blocco delle donne, quello più vicino al cancello. C’era un tavolino, fuori dai reticolati, liberi così, c’era un tavolino come questo, qui c’era seduto uno con una penna, io adesso non ricordo se era un qualsiasi esecutore materiale, scribacchino. E qui c’era il maresciallo Haage. La persona seduta chiamava il numero, il numero chiamato usciva, si presentava davanti al tavolino con il suo fagotto, il maresciallo Haage gli dava due sberle e poi lo mandava dall’altra parte.
Rosetta: Venivano chiusi tutti, questi che partivano, in un blocco che veniva vuotato.
Mariuccia: Ma prima di partire li mettevano lì, li schieravano, li ho visti io.
D: Quindi uomini e donne.
Mariuccia: È chiaro che prima, per farli andare sul camion li dovevano pur far uscire dal blocco. E facevano questo appello, io non so che significato avesse, e mi ricordo che mi faceva un’impressione spaventosa la forza di quest’uomo che stava lì a dare duecento, centocinquanta, centosessanta sberle alla gente, ma deve avere una forza da leone, perché l’ho visto. Non è che l’ho visto tutte le volte, l’ho visto un paio di volte.
D: Uscivano a piedi dal campo?
Mariuccia: No, no, venivano caricati sui camion. Ed un altro particolare che le dico io, che ho visto con i miei occhi, le poche cose che ricordo, non sono per niente eroiche, le pedate nel sedere che davano agli ebrei per farli salire. Io pensavo, penso fossero ebrei, perché uno di quelli presi a calci nel culo si chiamava Levi. E suppongo che anche gli altri, che come lui venivano fatti salire sui camion a pedate, fossero ebrei, perché alcuni sapevo che erano ebrei, perché come dico, delle volte venivano lì nel nostro corridoio a dire il loro nome, mio papà prendeva il nome, a dire la loro famiglia, e così via dicendo. E questo Levi, uno piccolino così, aveva detto d’essere l’unico sopravvissuto, che i suoi familiari erano già stati deportati e non sapeva più dov’erano. E quello lì lo hanno fatto salire proprio a calci nel culo, sul camion, questo l’ho visto con i miei occhi.
D: Dentro nel campo poi c’erano delle officine, no? Si lavorava all’interno del campo.
Mariuccia: Sì, c’era la lavanderia, c’era la falegnameria, c’era il magazzino, non so se ci fosse l’officina meccanica, quello non me lo ricordo.
Rosetta: C’era tutto quello che si riferiva all’elettricità, dove si aggiustava, si facevano dei lavori per quelli della Gestapo, aggiustavano le loro radio, tutte le apparecchiature.
Mariuccia: Gli elettricisti. Credo ci fosse anche una specie di sartoria, o guardaroba, dove aggiustavano la roba.
Rosetta: Sì, c’era la sartoria, sì. Ho lavorato anch’io una settimana.
D: In sartoria?
Rosetta: Sì, dopo mi hanno proibito di farlo.
Mariuccia: Per fare qualche cosa, perché era micidiale non fare niente.
D: Certo.
Mariuccia: Adesso che hanno riaperto il processo Priebke sono venuti a cercare informazioni di tutti i tipi.
D: Da voi?
Mariuccia: Sì, perché pare che tutte queste vicende fossero in parte anche connesse con il caso Priebke.
D: Ho capito.
Mariuccia: Perché questo Priebke, secondo me, anche lui era un agente segreto alla fine. Erano tutti, diciamo, sospetti di connivenza con gli alleati, a loro premeva di salvare la pelle, di salvare il loro corpo dalle SS. Quindi bisogna orientarsi su questa mentalità.
D: Dicevo, Mariuccia, la liberazione quando è arrivata?
Mariuccia: Ma io sono stata scarcerata, mi hanno chiamata al comando, 4134, è venuto Haage in cella e mi ha detto: “Nulli Maria, nacht Verona”. Io ho detto “Cosa mi portano a Verona”, perché erano i primi di marzo, “cosa vado a fare a Verona?” Niente, mi hanno messa su un camion, questa è la mia, dopo la sua la racconterà lei, alle due del pomeriggio. Alle quattro di mattina siamo arrivate a Verona, ma io avevo capito, su quel tragitto lì, perché ci siamo fermati non so dove, in mezzo a due soldati, che c’era già un’aria di sfacelo. Si vede che loro avevano paura dei partigiani, non so, andavano, siamo arrivati alle quattro di mattina a Verona, ma non siamo entrati in città. Siamo stati molto lontano. Mi hanno fatto portare una cassetta di munizioni, e mi hanno fatto andare, io non ce la facevo, avevo la febbre, mi hanno fatto entrare in una specie d’ufficio, dove c’era un nanerottolo così, quelli dell’ultima ora, un giovincello, che ha cominciato a dirmi: “Partisan, partisan”. Io ho detto di no, “No partigiano, sono un ostaggio”. Ed ha cominciato a sfottermi perché io studiavo filosofia e mi diceva: “Solo Germania grande filosofia”. Mi ha fatto un effettaccio, poi niente, mi hanno mandata giù nelle celle e mi hanno lasciata lì. Non so, tre, quattro giorni, non diceva niente nessuno. Io chiedevo di questo Eisenstein e nessuno mi diceva niente, poi ad un certo punto hanno aperto la porta, io sono andata con una, il biglietto non ce l’ho più, con una scritta nella quale c’era che io dovevo presentarmi tutte le mattine alla SS di Brescia, dove c’era questo Leo, una cosa che per me era totalmente insensata, e cosa che io facevo tutti i giorni, perché mi premeva di stare tranquilla. Ecco, questa è stata la mia liberazione.
D: Mentre invece la vostra, Rosetta?
Rosetta: La nostra è avvenuta…
D: Quindi Mariuccia è partita.
Mariuccia: Io sono partita, ho qui due lettere che ho scritto a loro, ma che non sono mai arrivate.
D: Mariuccia è partita e voi vi siete trovati soli in cella?
Rosetta: Soli per modo di dire, perché eravamo ancora in cinque.
D:Della famiglia?
Rosetta: Sì, della famiglia.
D: Cioè non vi hanno dato motivazioni del perché Mariuccia era stata mandata a Verona?
Rosetta: No, no, mai. Niente.
Mariuccia: Che poi a me avevano detto che poi avrebbero liberato anche loro, presto, entro un mese, avrebbero liberato anche loro, mi dicevano così. Però mi chiedevano di collaborare, di dire se sapevo dove erano i Bonomelli, di andare nelle Ausiliarie, insomma mi facevano delle cose che non avevano senso, perché dopo un mese e mezzo è finita la guerra. Si preparavano il terreno per non farsi ammazzare, secondo me.
Rosetta: Dopo il 20 di aprile abbiamo visto che sul camminatoio intorno piazzavano delle mitragliette in più, chiedevamo a quelli che uscivano che cosa succedeva, “Ah, niente”, dicevano, “niente, noi vediamo sempre i tedeschi e qui ci sono sempre i tedeschi”. “Ma cosa dicono sui giornali?” “Ma”, dice, “dove andiamo a lavorare noi ci sono dei giornali tedeschi, ma non si sa niente. Dicono che resistono.” Verso il 23 o il 24 aprile non è più uscito nessuno a lavorare, più nessuno. Si faceva però sempre la solita adunata della mattina, la prima sirena, la seconda sirena, eccetera, però bisognava stare molto, ma molto chiusi, si poteva uscire solo un paio di volte, anch’io con il bambino non potevo andare in giro come facevo prima. Ci aprivano poco la porta in fondo alle celle, si poteva stare lì nel corridoio. Il 29 aprile era domenica, perché l’ho proprio scritto. Verso le quattro sentiamo che si apre la porta in fondo, passi un po’ pesanti, e si spalanca la porta della cella e c’è il maresciallo Haage e dietro due soldati, me lo ricordo benissimo perché uno aveva in mano sulle due braccia i vestiti, e l’altro aveva un secchiello dove c’erano dentro le nostre scarpe. Allora ci dicono di vestirci,l’interprete dice: “Vestitevi che andate al comando”. Lì nella cella di fronte alla nostra, non mi ricordo più chi c’era dentro, qualcuno che ha assistito dallo spioncino alla scena e ci diceva: “Non muovetevi, ma dove andate? Ma non sapete che vi fanno fuori? Non andate, non dovete uscire.” Comunque i soldati hanno aspettato, quando noi ci siamo rivestiti con le nostre cose, hanno preso le tute e ci hanno accompagnati al comando, e siamo andati su al comando, c’era il maresciallo Thito, siamo andati dentro ed ha fatto una carezza a mio figlio sulla guancia, lui tutto, è stato molto contento, e poi ci ha dato il foglio di scarcerazione a ciascuno di noi e ci hanno messo fuori dalla porta. Allora noi, insomma anche sollevati da un lato, perché dicevamo: “Va beh, ci hanno lasciato così, senza neanche una lira in tasca, senza sapere neanche dove siamo esattamente comunque adesso vedremo”. Noi eravamo convinti che andando per esempio a Bolzano avremmo trovato non so, i liberatori dell’Italia, ed invece ci siamo accorti che lì c’erano tutti tedeschi, tutti, tutto era ancora occupato.
Mariuccia: È per quello che vi hanno dato il foglio di scarcerazione.
Rosetta: Eh beh certo, però avevamo anche paura di far vedere quel foglio di scarcerazione nei quattro giorni che abbiamo impiegato per arrivare a casa, e caspita…
D: Con cosa siete arrivati a casa?
Rosetta: Con i mezzi un po’ di fortuna, mezzi di fortuna e parecchia strada a piedi, ti faccio vedere dov’è Mori?
Mariuccia: Sì, l’ho visto, ho guardato sulla cartina.
Rosetta: È a 12 chilometri da Riva.
D: Tra Rovereto e Riva del Garda, Mori.
Rosetta: Sì, tra Rovereto e Riva del Garda ma più vicino a Riva del Garda che a Rovereto.
Mariuccia: Ma non passa la ferrovia, da Mori, però.
D: Sì, passa.
Rosetta: Sì, passa.
Mariuccia: La ferrovia Verona – Brennero passa da Mori?
Rosetta: Anche la strada passa, andando in macchina vedi che c’è scritto Mori. Sì, anche sull’autostrada c’è l’uscita.
D: Quindi avete fatto tutto il viaggio…
Rosetta: Prima siamo andati all’Aprica, con l’idea di dire che forse là all’Aprica, alla Mendola, oh, mi scusi, alla Mendola, con l’idea che alla Mendola, pensavamo che dopo, allontanandoci dalla Mendola avremmo trovato il sistema per andare a casa. Invece lì alla Mendola abbiamo visto che non c’era niente da fare. A parte il fatto che mio padre non voleva neanche che io fermassi i camion con i tedeschi, perché diceva “No, non li devi fermare, non devi farti prendere su, non devi fare niente.”
Mariuccia: Eh, sì, aveva ragione.
Rosetta: Poi dalla Mendola siamo tornati a Bolzano, a Bolzano ci siamo incamminati verso Trento, appena uscita da Bolzano un camion tedesco era fermo e lì c’era un tedesco che parlava italiano, sì insomma parlava, allora io ho detto: “Non potrebbe portarci un pochino in giù che siamo qui”, eccetera, però mio padre mi diceva: “Non fargli vedere il foglio di scarcerazione, eh?” Allora lui ci ha caricati e ci ha portati ad una decina di chilometri da Trento. Poi siamo arrivati, intanto era venuta sera, lì ci siamo internati dentro e abbiamo dormito in un cascinale, ci hanno lasciati dormire in una specie di veranda semi vuota, ma un freddo dell’accidente, perché non avevamo neanche niente per coprirci. La mattina ci siamo alzati presto, e sempre all’interno, siamo andati verso Rovereto. È stato a quel punto che abbiamo visto che c’era, tutto il territorio intorno, dove non c’erano più soldati. I tedeschi non c’erano più. Abbiamo incontrato soltanto una pattuglia di tre persone ed era la cosiddetta terra di nessuno. Attraversato questo abbiamo dormito lì vicino a Rovereto in un monopolio, in una specie di fabbricato dove c’erano i monopoli, c’erano le sigarette, che non c’erano più, sale e quella roba lì. Lì c’era parecchia gente che dormiva, anzi qualcuno ci ha anche dato una copertina per coprire mio figlio e la mattina del giorno dopo da lì abbiamo camminato e siamo arrivati a Mori, e quindi eravamo al 3 di maggio. A Mori il prete ci ha permesso di dormire in una sacrestia, ma è stata una nottata terribile, perché si sentivano delle cannonate ininterrotte e poi verso le tre o le quattro di notte come uno scalpiccio continuo di piedi, perché questa chiesa è quella che si vede passando; c’è un campanile, lì a Mori, provi a guardare, lei vede una chiesa che adesso è stata ritinteggiata di bianco, e vicino c’è un piccolo fabbricato che era la sacrestia, allora mi sono alzata e ho visto che lì passavano i tedeschi, proprio come si vede nei film, con le giacche aperte, disarmati, e si stavano ritirando. Sono andati avanti, per parecchie ore, saranno state le tre, le quattro del mattino, poi verso le sei e mezza o le sette, ci siamo incamminati, abbiamo detto “Andiamo a Riva”, arrivati dopo un paio di chilometri da Mori invece non si poteva più passare, cioè si poteva passare ma bisognava andare a fare un giro, siamo rimasti lì. Ad un certo punto, dalla parte opposta di questo cratere che oramai era un cratere enorme, abbiamo visto due camionette americane. Allora questi hanno fatto, una è venuta giù perché era un cingolato, e l’altra invece ha fatto il giro e ho detto: “Basta, adesso non andiamo più a piedi”. Infatti sono venuti lì, e allora abbiamo tirato fuori i nostri fogli di scarcerazione, ma quei due bei ragazzi lì americani, hanno preso, sulla camionetta, mia madre, mia suocera e mio figlio, ed io e mio padre ci hanno lasciati lì e ci hanno dato il nome della caserma dove potevamo andare a rintracciare mia suocera, mia madre e mio figlio e se ne sono andati. Noi siamo arrivati a Riva verso l’una o le due del pomeriggio, a piedi, insieme a tutta l’altra gente.
D: Quando vi siete ritrovati, poi?
Rosetta: Al 4 maggio ad Iseo.
D: Ad Iseo?
Mariuccia: Eravamo io e mia sorella che era uscita al 25, mi pare.
D: Dalla prigione?
Mariuccia: Dalla prigione, eravamo andate su in campagna dove eravamo poi in quel posto là perché c’era un casotto ad Iseo e ci hanno detto di venire a casa che erano arrivati.
D: Invece tuo marito?
Rosetta: Mio marito lo hanno lasciato andare quando hanno firmato il trattato di pace.
D: Perché lo avevano riarrestato?
Rosetta: No, no, no, mio marito aveva passato le linee e si era ripresentato un’altra volta al suo comando.
D: Ah. Lui sapeva che eravate a Bolzano?
Rosetta: Sì, lo sapeva perché quando lui è andato nelle montagne, a Piacenza, si è rivolto ad un sacerdote che si chiamava Bonomelli. Questo sacerdote gli ha detto: “Vai in questa località, con questo biglietto, vedrai lì c’è una formazione partigiana e loro potranno metterti in contatto con il tuo comando”. Lui è andato lì, si sono messi in contatto con il comando ma il comando ha dato subito ordine di tenerlo chiuso. Perché, caspita…
Mariuccia: Poteva anche essere una spia. Ma è successo anche a me, sa? Ah, ecco, questa è una cosa che mi ero dimenticata.
D: Cioè?
Mariuccia: Io sono andata dalla Magda, quando sono uscita, treni non ce n’erano, sono stata lì una notte o due a dormire. Lei aveva un amico che era un socialista, e mi ha detto: “Come mai tu sei uscita? Fammi un favore, fammi una relazione.” Io ho fatto una relazione, e quello tergiversava. Insomma pensavano che io fossi uscita prima perché avevo aderito a qualche …
Rosetta: Ah, sì, certo.
Mariuccia: Un altro particolare che mi viene in mente, quando il maresciallo Haage è venuto a dire “Nacht Verona”, il capo campo, era Alfi, è venuto lì con dei bigliettini, ti ricordi?
Rosetta: Sì.
Mariuccia: E me li aveva fatti cucire nella cintura, perché la paura che avevano loro era che alla liberazione del campo li mitragliassero tutti. Allora lui mi detto: “Tu fai così, qui non si può avere contatti con nessuno, allora vai a Venezia, vai dal tale”, un tizio che si chiamava Battistella, “il quale ti indirizzerà”, non so poi perché avrei dovuto andare fino a Trieste, “dal direttore del manicomio di Trieste che è in contatto con …” Non so. Io diligentemente sono sfuggita ai controlli delle SS che poi dopo mi hanno mandata a chiamare, perché dicevo “Devo andare a fare un esame a Milano”, facevo finta di andare a Milano e con mezzi di fortuna sono andata a Venezia, con questi biglietti che dovevano essere recapitati a chi veniva poi a difendere qui, penso io, il campo. Tutte robe che si fanno da giovani perché non si pensa alla stupidità delle cose che si fanno, comunque io ho rischiato di mio perché sono saltata sui camion, ho preso i bombardamenti, sono andata a Venezia, lì mi sono trovata sola, senza soldi anch’io, non sapevo cosa fare, sono andata da questo Battistella il quale non ha voluto assolutamente saperne di ricevermi. E dopo, non so come, da Iseo, attraverso mia cognata Magda e mio cognato che lavoravano a Verona, nell’Ufficio Tecnico Erariale, mi hanno detto di tornare immediatamente perché quelli delle SS mi avevano cercata. E qui finisce la mia storia. Perché le persone a cui io a Trieste avrei dovuto consegnare quello che mi avevano messo dentro nella cintura erano state uccise tutte. Dopo io non ho più pensato d’andare a sentire com’era questa storia, ma mi sarebbe piaciuto sapere che fine avevano fatto questi personaggi.
Rosetta: E quel Battistella?
Mariuccia: E quel Battistella lì, antipatico, io non sono più andata a cercarlo. Perché se fossi andata a cercarlo gli avrei detto: “Ma lei è un imbecille, è un cretino.” Forse aveva paura. Dopo sempre lui, Alfi, mi ha dato un indirizzo di una certa signorina Boato, che mi avrebbe ospitato, io sono andata da questa Boato e ho detto: “Senta, mi manda il tal dei tali” “Ah no, no ma io…”. “Senta, io in strada non ci sto, io vengo a dormire a casa sua”. Sono andata lì e ho dormito due notti, e poi sono tornata a casa.
D: Questo a Verona?
Mariuccia: A Venezia, in questa casa, e poi io non potevo stare via tanto, perché mi cercavano, va beh, se non fossi più tornata non mi facevano niente, per carità, però loro erano là dentro, cosa ne so io? Che si mettono a fare i pazzi. E questa tizia aveva nascosto in casa suo fratello, mi verrebbe il gusto di sapere se quel Marco Boato che è un personaggio del parlamento, non so di che corrente, è imparentato con questa tizia qui, Marco Boato, si chiama.
D: Sì, sì, Boato.
Rosetta: Però è giovane, non può essere lui.
D: No, non è lui, lui è giovane.
Mariuccia: Sarà di quella famiglia lì?
D: Ah, può darsi.
Mariuccia: Guardi, adesso le faccio fare una risata. Abitavano a Venezia al Ponte delle Tette. Che io, ero una ragazzina, lì sperduta, e mi vergognavo a chiedere dov’era il Ponte delle Tette, adesso non si vergognerebbe più nessuno, ma allora ai miei tempi era così. E tutti, quando chiedevo il Ponte delle Tette, si spatasciavano dal ridere. E la situazione non era ridicola.
D: Certo.
Mariuccia: Non c’era niente da mangiare, non c’era niente da dormire. Non si sapeva come fare a campare. Questo Gian Antonio era di Milano?
D: Era un trentino, della Val di Non che però era al convento dei frati cappuccini di Milano, in che via, questo non me lo ricordo, ce l’ho scritto, però eh. Sant’Ambrogio, mi pare.
Mariuccia: All’interno, avevo disegnato il maresciallo Haage che faceva l’appello, perché mia sorella non si ricorda, forse perché lei stava nella cella, ma io con la curiosità di fare i disegni mi ero nascosta dietro gli angoli delle baracche, siccome godevo di una certa autonomia, essendo un prigioniero speciale come lei, non mi dicevano niente, però non mi avevano visto disegnare. Poi ho disegnato la punizione che hanno fatto ad un tizio che aveva rubato, al quale hanno legato le braccia dietro e gliele hanno rotte a legnate. Insomma avevo, guardi, saranno stati una ventina di schizzi di questo genere. E c’era una signorina inglese, che era l’istitutrice di casa Besana, quello dei panettoni, che mi insegnava un po’ l’inglese, veniva lì nella nostra cella.
D: Ma lì nel campo era?
Mariuccia: Sì, nel campo, era come prigioniera civile, inglese. Era ammiratissima di questi fogli, mi diceva di non perderli. Perché erano molto belli, poi ho fatto altri ritratti, alle persone alle quali poi li ho dati, una era questa Luciana Menici di cui non riesco a trovare l’indirizzo e uno era un certo Bianco.
D: Com’è la storia del sabbiolino, allora?
Mariuccia: Certo, siccome mio nipote piangeva sempre, quando chiudevano la cella ed andava avanti un’ora a dire “Aprimi, aprimi, aprimi” e poi si metteva a cantare, bisognava cantare. Allora io, anche perché di giorno non si sapeva cosa fare con questo bambino, facevo sempre i disegni delle fiabe. L’unico che mi era rimasto era questo disegno del nano sabbiolino, c’era un gran castello, ma era piccolissimo, grande come questo foglio, favoloso con tutte le stradine rotonde un ponte, e su questo ponte passava il nano sabbiolino, con il suo berretto a punta e la lanterna in mano, e il sacchetto della sabbia, lui guardando questo disegno, si divertiva e si quietava. Poi avevo fatto altri disegni che sono andati persi, sempre per il mio nipotino li facevo. Ma quelli che mi dispiace di più sono i disegni delle adunate, delle partenze, perché quelli erano veramente. Mi ricordo che ne ho fatto uno una volta, con il maresciallo Haage con il frustino dietro, gli stivali e avevo fatto il sedere quadratissimo, proprio sembrava un quadro cubista, con questo culo grosso, tutto dritto, quello me lo ricordo ancora. Li facevo con la matita o con la penna, ma purtroppo io non li ho più. Mi è rimasto questo.
D: Che cos’è quello?
Mariuccia: Questa era la cella dove eravamo, fatta là. Dopo, siccome vedevo che si stava cancellando, perché la matita è molto delicata, c’era una mostra intitolata “Il convivio”, aveva come tema il convivio. Ho detto, pensa, ti faccio vedere io il convivio. Allora ho fatto, un paio d’anni fa, ho preso questo disegno e da questo ho tratto quell’incisione che è lì, e l’ho intitolato: “Natale nel Lager”, più bel convivio di quello.
D: Prima, Mariuccia, raccontavi un episodio molto importante di don Berselli, che veniva nella vostra cella.
Rosetta: A grattarsi il formaggio sulla zuppa.
Mariuccia: Se la mangiava solo, solo, non ha mai dato un cucchiaio neanche al ragazzino.
D: Neanche?
Mariuccia: Mi ero fatto un’idea negativa di questo don Berselli, però adesso che sono più vecchia, diciamo che sono vecchia, capisco che l’essere umano è così prevalentemente, e se uno vuole sopravvivere deve essere così.
D: Ti ricordi anche di don Vismara?
Mariuccia: Di don Vismara mi ricordo poco, perché era uno che parlava poco, era una persona sempre depressa, non aveva niente da dire. A mia impressione non comunicava insomma, mentre don Berselli era un uomo intelligente che comunicava, don Gaggero lo stesso, don Vismara era proprio un prete, non so come dire, può darsi che fosse anche intelligente, nel senso che in quei posti lì è meglio parlare poco, delle volte una parola detta in più.
D: Mariuccia, che cos’è che ti ha aiutato a sopravvivere all’interno del Lager?
Mariuccia: Ma sa, da giovani si hanno delle risorse spirituali e psicologiche pazzesche, che mi ha aiutato a sopravvivere era la convinzione che tutte le cose finiscono, e che se avessi avuto pazienza sarebbe finita anche quella lì. Poi mi ha aiutato a sopravvivere il sentirmi, guardi che questo è un concetto che può sembrare, come dire, romantico. Il sentirmi parte di un tutto che era coinvolto in una grande tragedia, e quasi quasi stavo meglio lì, di quando sono uscita. Perché quando sono uscita mi sono trovata così sbandata, sola, con questi fascisti che mi correvano dietro a tutte le ore, avevo sempre due fascisti davanti alla casa che mi sorvegliavano. Volevo dire che avevo perso il mio essere ingranaggio, il mio essere piccola rotella in un ingranaggio, che faceva, che macinava un qualche cosa e di cui io facevo parte. E di cui avevo anche una parte non puramente passiva, perché fa questa faccia?
D: Perché occorre essere molto saldi nelle proprie convinzioni.
Mariuccia: Le dirò che per me il Lager è stata una sofferenza morale pesantissima, perché io di notte avevo delle forme d’angoscia che non dipendevano dal fatto che io avevo paura o avevo fame, ma dall’incapacità che avevo di rendermi conto del perché succedessero queste cose, del perché una persona venisse presa, portata in Germania, presa a calci mentre saliva su un camion, usciva proprio fuori da una mia capacità di comprensione umana quello che vedevo.
D: Cioè non c’era nessuna spiegazione logica, razionale.
Mariuccia: No. E non c’è neanche adesso. Non l’ho mai trovata.
D: Infatti.
Mariuccia: E poi l’angoscia, perché io avevo anche un ragazzo, col quale ero molto affezionata, che sua madre lo aveva obbligato ad arruolarsi nella Monte Rosa, e lui si era fatto mandare in Piemonte, sulle vette, se lei conoscerà mio marito vedrà che uomo è, ha capito? E lui era disperato perché ha capito che io ero nel Lager e cercava di fare di tutto per farmi uscire, ha capito? Beh, questa è un’altra cosa, poi dopo io non sapevo niente di dove era lui, cioè sapevo che era là, che non faceva per carità i rastrellamenti, era stato mandato a costruire, alla guerra contro i francesi, mi dica lei il senso. Quindi c’era anche questa assoluta mancanza d’un senso nelle cose che vedevo fare, perché, mi dica la verità? Ha senso prendere la gente, caricarla sui camion, mandarla in Germania, ha un senso impiegare energie pazzesche per tenere tutta questa gente nei Lager? Anche da un punto di vista pratico non ha senso. Se loro non avessero sprecato tutte le loro energie in questa costruzione abnorme, impiegato uomini, armi, forse forse riuscivano a fare meglio la guerra, penso io. Addirittura da un punto di vista pratico, secondo me era una cosa cretina.
D: Beh, ma lì dovevano eliminarli tutti, eh? E l’unico modo per eliminarli era …
Mariuccia: Ma è questo che non ha senso.
D: Lo so che non ha senso. Però il loro progetto, la loro ideologia era quella lì.
Mariuccia: Sì, l’ho letta, ho letto la storia del Terzo Reich e l’Ordine Nuovo di Hitler. Dopo, quello che non capisco, è che ci fossero, anche nel comunismo ci fosse questa, guardi, io le dico subito che non sono una comunista, non lo sono e non lo sarò mai perché purtroppo il mio spirito è più anarcoide. Io mi definisco liberale ma forse sono più anarcoide che liberale, poi una mia convinzione di tipo più profondo m’impedisce d’accettare qualsiasi ideologia che minacci la libertà, anche di pensiero. Preferisco il disordine, la confusione, la difficoltà del vivere, l’errore a qualsiasi cornice che mi obbliga a vedere la verità che mi vogliono far vedere gli altri. Questo è il mio modo di pensare.
D: Ritornando un attimo ai disegni del Lager, la documentazione che voi siete riuscite a portare via, portare fuori è, oltre a quell’originale lì, il testo…
Mariuccia: Alcune lettere che ho scritto al mio moroso e che lui ha conservato, e che sono anche abbastanza interessanti perché parlano di queste cose di cui ho parlato io adesso. Naturalmente non si poteva scrivere quello che si vedeva, però s’intravede l’atmosfera di questo campo, si intravede molto bene. E poi questi disegni, il rigaudon, poi ho questa lettera che hanno scritto gli ebrei a mio padre.
D: Gli ebrei hanno scritto questa lettera al babbo?
Mariuccia: Questo tizio era un ebreo di Genova, perché finita la guerra, dopo mio padre si è dato da fare per rintracciare quelli che aveva conosciuto. Questa lettera, scritta da questo ebreo di Genova, lei legga. Qui parla di molti che sono partiti da Bolzano. Dice: “Non so se la presente la raggiungerà, ma l’invio ugualmente per dare loro mie nuove. Dopo la mia partenza avvenuta, come loro si ricorderanno, il 14 dicembre ’44, credo di essere l’unico superstite di quella spedizione di ebrei, tutti gli altri, da quanto ho potuto sapere, sono periti a Flossenbürg ed altrove. Io ho percorso un ben duro calvario a Flossenbürg, Hersbruck e Dachau portando in spalla macigni e tronchi d’albero, facendo una fame nera. Sono tornato il 4 luglio in Italia dove ho ritrovato la famiglia al completo, ossia la mamma ed il mio maggior fratello con moglie e figli che poterono nascondersi e non ebbero noie. Athos Polacco, a Bolzano nella squadra dei gabinetti, è perito a Hersbruck di tifo e diarrea sanguinosa. Mentre gli altri li lasciai tutti a Flossenbürg dove furono visti ancora in vita il 23 gennaio. Pare che anche la mamma di Athos e sua sorella Iride siano perite. Altri dicono che sono illesi, altri ancora a Fürstenberg, vicino a Berlino, ma notizie precise non ce ne sono. Quanto a me ho avuto parecchie fortune, soprattutto quella di stare a lungo nell’infermeria a causa del congelamento dei piedi. Non solo, ma di esserci potuto entrare ed esserci stato molto lungo ed intanto è avvenuta la liberazione. […] Non mi dilungo in altri particolari perché sono tutti orribili, a raccontarli tutti ci vorrebbe un romanzo. Ora sono di nuovo con la mamma e ieri sera essa ha voluto festeggiare con speciale rassegna di vivande la data anniversario della mia partenza per la Germania. Chissà che cosa saprà fare ancora il 4 luglio del ’46, data del mio arrivo. Vi saluto e sto bene, come condizioni generali, ma il piede sinistro mi dà ancora parecchie noie, il medico dice che sono cose lunghe ma alla fine guarirà. Il piede destro invece, che pure era congelato, mi ci hanno amputato il terzo dito, in quell’infermeria che non capivo bene se fosse una stalla o un bordello. Sarò ben lieto se vorranno darmi loro notizie, ho saputo che qualcuno che era a Bolzano con loro è stato liberato a Natale insieme con quel musicista tedesco alto come una cattedrale e grosso in relazione […]”.
D: Mariuccia, questa lettera qui, questo Paolo, l’ha scritta al vostro babbo per l’aiuto?
Mariuccia: Per l’aiuto che aveva dato …. Anche in questa lettera ci sono delle cose pazzesche. “Ho ricevuto la di lei graditissima lettera del 7 corrente e la ringrazio, con vivo piacere ho appreso che loro tutti sono in ottima condizione di salute e hanno ripreso la solita vita. Ho letto con interesse tutto ciò che ella mi scrisse, ma quando avrà tempo e volontà la prego pure d’informarmi delle circostanze nelle quali fu liberato il campo di Bolzano. Che ne fu di Hans e di Werner? Dove sono andati a finire quei figli di cani d’ucraini? È vero che il maresciallo Haage è stato impiccato dagli internati? E dove finì quella sua famosa moglie, quella grassa impiegata del comando? Intanto posso dirle che si è salvato Stefano Vela, il calzolaio napoletano che lavorava a Bolzano nella calzoleria e che fu inviato in Germania in seguito, pare ai dissidi col capo calzolaio. Fu a Flossenbürg e vi arrivò pochi giorni dopo la mia partenza e vi conobbe Fontanella e tutta la compagnia. E’ tornato a Genova, molto malandato in salute e ora si è assai rimesso. Però ci ha rimesso i denti, buttatigli giù a pugni dalle SS del campo. Quel tal giudice piemontese di cui lei accenna, Emilio Sacerdote, che si spacciava per Emilio Dote, l’ho lasciato a Flossenbürg e altro non so. Quasi tutti i parenti di quei disgraziati mi hanno scritto chiedendo notizie dei loro cari, ma non certo quelli del predetto sacerdote. Per quanto riguarda Danilo Panciatici, temo forte che sia perito. La vigilia di Natale del ’44 eravamo tutti quanti, gli ebrei italiani, i più validi, in un punto del cortile del campo ed eravamo occupati a impilare baracche smontate agli ordini dell’ingegner Lowenthal che funzionava in certo senso da Vorarbeiter. Mentre io ero da una parte del cortile vennero delle SS, prelevarono Dante e Italo Momigliano, l’ingegner Italia, l’ingegner Schoenberg, Viro Endrec, Curiel, Sauro Ascoli, Danilo Panciatici e li portarono via. Ho saputo che l’ingegner Italia ed i due Momigliano risultano deceduti dagli archivi di Flossenbürg, ma degli altri non so nulla. Io mi salvai da quella spedizione perché non mi videro. Ciò che mi meraviglia è che manchino pure notizie di Lowenthal, in quanto a Flossenbürg era riuscito a farsi aiutare dai capi del blocco e gli avevano levato il nastro giallo da ebreo e lo avevano mandato niente meno che a controllare la locale fabbrica di aeroplani Messerschmitt. Quanto a me, Iocas, a Flossenbürg ero riuscito a lavorare in sartoria, lavoro assai ambito perché retribuito con viveri supplementari. Quando arrivai a Milano seppi di sicuro che allora, il 5 luglio, ancora non vi erano nuove. Jovel Liss e quell’altro turco poco simpatico e bigotto erano riusciti a far entrare dei pezzetti d’oro nel campo e a Flossenbürg con quel sistema si era procurato un incarico, non so quale, al famigerato blocco dei morti dove venivano inviati gli incurabili, i vecchi, i minorati ai quali veniva fatta fare una cura intensiva di calci nel petto e altrove, nonché a sei ore giornaliere di gelo bavarese fuori baracca. Il capo blocco era il più ricco di tutti, potendo contare su venticinque, trenta morti giornalieri aveva a disposizione venticinque, trenta minestre in più al giorno, venticinque, trenta pezzi di pane e margarina in più al giorno che commerciati con gli altri blocchi gli davano un benessere particolare. La ringrazio tanto per le sue frasi cortesi ma non fui io ad afferrare la fortuna, fu lei stessa che si sbracciò ad afferrare me con una serie di casi e coincidenze una meglio combinata dell’altra”. Dopo dice che sarebbe venuto a trovarci, invece non è venuto, e poi fa un’offerta commerciale. Mio padre faceva il conciapelli, e dice che vende, “Vendiamo un fottio d’olio di pesce in alcune concerie, ne avremo dell’altro, se l’offerta le interessa mi avverta, possiamo disporre anche di altri prodotti chimici. Lascio di scrivere per non farla tanto lunga, che ci sarebbe materia per un romanzo intero, ricorda fra i genovesi Emilio Terreni, quello così grande e grosso ed il commendatore Roberto Lepetit, sono periti tutti e due in Germania. Tanti cordialissimi saluti a lei e famiglia”. Paolo Weisser.
D: È sempre lui, è sempre Paolo?
Mariuccia: Sempre lo stesso. Perché mio padre poi ha risposto, ha chiesto, e purtroppo di queste lettere ce n’erano tante, sono andate perse quando è morto mio padre, perché io non ho avuto l’accortezza di fare subito lo spoglio di tutto quello che c’era in casa. Ho fatto lo spoglio ma molte cose, ero sola, ho impiegato tre mesi a mettere a posto le carte. Molte cose mi sono sfuggite. Comunque sono interessanti, vero?
D: Parecchio interessanti. Sono documenti importantissimi.
D: Quelli sono documenti, non sono fantasie. Questi Momigliano…
Mariuccia: Erano i cugini del famoso Momigliano.
D: Ma loro sono originari di dove?
Mariuccia: Io credo di Torino.
D: Perché Arnaldo Momigliano è di Caraglio, provincia di Cuneo, lo storico.
Mariuccia: Erano cugini diritti dello storico Momigliano.
D: Allora sono piemontesi, insomma.
Mariuccia: Io li ho conosciuti perché erano capo cessi, e siccome si avvicinavano spesso alle nostre celle, perché gli si dava qualcosa, poi scambiando le parole, scambiando discorso, ci si conosceva, si capiva che erano persone con le quali era possibile avere un contatto un po’ umano, diciamo, ci si erano affezionati molto.
D: Poi avete recuperato la poesia del francese dedicata a Ennio?
Mariuccia: Sì, che mi dispiace non avere più il testo della canzone dei prigionieri che aveva scritto Gurtler. E l’aveva scritta, mi aveva promesso che me l’avrebbe data, io non ricordo guardi, penso che non ci fosse perché se no l’avrei conservata come ho conservato questa.
D: Poi c’è il diario.
Mariuccia: Il diario di Vittorio Duca. Vittorio Duca, quando io sono uscita, mi ha accompagnato sulla porta della cella e mi ha detto: “Ti raccomando Mariuccia, vai a casa e datti da fare per la Resistenza, guarda che bisogna fare qualcosa.” E infatti io così ho fatto, e ho cercato poi di fare quello che potevo fare, rifornivo i partigiani di cartucce, perché oramai mia sorella era in prigione, andavo a prenderle al poligono di tiro, e dopo, si chiamava Boccacci, Leone Boccacci, il 25 aprile nei pressi del poligono transitava una camionetta di tedeschi, con su due tedeschi. Hanno alzato le mani perché hanno visto della gente armata, facendo segno che si arrendevano. Uno di quegli imbecilli, mai sufficientemente classificati come tali, del 25 aprile con i fazzoletti della liberazione, hanno sparato ad uno e lo hanno ucciso, l’altro ha preso la camionetta e l’ha girata ed è andato via. Dopo un’ora sono arrivati lì in un drappello e hanno facilitato tutti quelli che c’erano nel poligono, sedici persone, c’era anche un ragazzo di quattordici anni, una ragazza di quattordici anni che era mia amica, perché si andava lì a fare gli allenamenti, si andava lì a sparare. Per dire le cose che succedevano. E questo tizio che durante tutta la Resistenza aveva procurato cartucce sottobanco, che si andavano a prendere là in bicicletta e si mettevano nello zaino e si portavano fuori ad Iseo, che poi venivano a prenderle dal monte, lì alla nostra casa, ecco perché dicevo che eravamo già noti come rompiscatole diciamo. Io non ho fatto niente per carità, zero, però c’era questa situazione.
D: Mariuccia, dopo il Lager, in questi anni dopo il Lager, cosa è rimasto dentro di voi di quell’esperienza? Cioè vi è costata, durante la vita, nel ristabilire i rapporti, per esempio con gli amici a Iseo, con i conoscenti, con altri?
Mariuccia: Guardi, c’è stato un periodo in cui avevo un certo fastidio a parlare con gente che sapevo che era d’idee piuttosto di destra, diciamo, fasciste. Perché io ho constatato che la mentalità fascista, non è perché uno sia fascista, ma è proprio la rotella del cervello che fa essere fascista uno anche se è comunista o se repubblicano. Perché è una specie di volontà di sopraffazione, di mancanza di senso critico, di atteggiamento autoritario. Questa è la mentalità fascista, il non voler ascoltare le ragioni altrui, d’aver in mano la verità, io la penso così. Poi la prima cosa che ci ha afferrato è il ritmo del vivere che dovevamo riprendere e che avevamo tralasciato. Io per esempio avevo fatto cinque o sei esami in tutto all’università; la mia preoccupazione è stata quella, in due anni ho finito dodici, tredici esami d’università di filosofia, quindi avevo sempre la testa sui libri e non mi sono neanche…, e poi ci si interessava un po’ della vita politica. Mio padre era un vecchio liberale, era stato ai tempi di Giolitti, un giolittiano anti, come si dice? Contro l’entrata in guerra insomma, neutralista, sa che allora c’erano. Poi ci siamo messi a fare anche lo sport e credo che uno psicologo direbbe che c’era la volontà di rimuovere quest’esperienza che in fondo poi è stata un’esperienza breve, profonda fin che vuole, però era stata un’esperienza breve non ci aveva costretti, eravamo sopravvissuti. Prima cosa che io ho detto, noi siamo degli esseri fortunati, questo ho pensato. Abbiamo avuto questa esperienza ma siamo persone felici, perché siamo venuti a casa integri, non ci hanno picchiato, non ci hanno ammazzato, ci hanno privato d’un paio d’anni di vita, ma adesso noi ce la riprendiamo. Questo era il discorso che si faceva. Poi c’era un certo ottimismo verso la costruzione di una nuova società, che era quella che ci aveva un po’ sostenuto, perché nella mia famiglia noi abbiamo sempre ricevuto un’educazione di tipo liberale. Noi la dittatura da ragazzi la guardavamo con simpatia perché eravamo un po’ scemi, mettevamo la camicetta, andavamo a fare l’adunata, ma in casa ci davano degli imbecilli. “Voi non sapete che cosa vuol dire vivere in un regime di libertà. Questa è dittatura”. Mio padre quelle cose lì ce le aveva spiegate. Poi dopo invece un po’ alla volta ho capito che erano imbecilli i fascisti ma erano imbecilli anche gli antifascisti. Cioè che la stupidità si divideva in parti uguali nell’umanità. Anche se si tenta di costruire una società democratica e libera ci sono sempre delle cose che io non capisco e che perlomeno non rispondono a quello che io pensavo fosse una società democratica e libera. E come dico dopo c’è stato anche un periodo, non vorrei dire una stupidaggine, in cui quasi la gente non voleva sentir parlare di queste cose. E la gente non ne vuole sentir parlare neanche adesso. La gente non vuole essere disturbata, vuole mangiare, bere, dormire e fare il week-end, possibilmente rimanere ignorante perché se uno non è ignorante affina anche la sensibilità e quindi è esposto di più ai colpi di fortuna come diceva Dante. Quello che ho notato io è che eravamo come degli estranei. Non entravamo, io non sono mai entrata nella società a pieno ritmo, mi sono sempre sentito un po’ diversa, mi scusi, sarà una forma di presunzione.
D: Ma oltre a sentirsi diversa…
Mariuccia: Sarà anche per il mio carattere, intendiamoci, non perché sia stata nel Lager, perché forse sarei stata la stessa cosa. Io per esempio certe forme d’insensibilità verso le cose che si vedono non riesco a capirle, mi danno fastidio. Una cosa che mi emoziona e agli altri non dice niente, ce ne sono moltissime di cose, io m’interesso, mi emoziono, mi agito per questo o per quello, benché sia già una vecchia, voglio dire, non ho perso la capacità d’indignarmi, la capacità di ammirare … Appena usciti, a casa abbiamo ripreso a vivere come tutti, no? Non siamo andati a cercare, non so, a dire “Noi siamo gli eroi, noi siamo i martiri”, perché non è neanche vero tra l’altro, perché quando uno salva la sua pelle viene fuori un po’ intero, che eroismo è? Però quello che, forse è una cosa curiosa quella che le racconto, che è emblematica. Io ho fatto l’esame di latino con un professore severissimo, era un luminare della lingua, il professor Castiglioni, nientemeno che autore. Vado dentro, tutti avevano una paura matta perché bocciava di brutto, io avevo questa specie di sicurezza che mi veniva un po’ dal fatto che avevo fatto lo sport, e avevo il senso sportivo anche della sconfitta, e un po’ dal fatto che avevo sulle spalle delle esperienze, di fronte alle quali l’esame di latino, sì, era una cosa preoccupante, ma non drammatica. Allora vado dentro, ho fatto bene tutto il mio esame, e lui mi fa leggere un brano di Seneca. Io l’ho letto e tradotto correttamente, mi guarda e mi fa: “Signorina, la potenza del latino lei non sa neanche dove sta di casa”. Io ho fatto un pensiero, non so se si può dire, internamente un turpiloquio, ho detto: “Va a farti friggere te e la tua potenza del latino, perché a me in questo momento non me ne frega niente”. Ero uscita dal Lager da sei o sette mesi. Ed un’altra volta, durante una lezione di filosofia teoretica, era sorta una discussione, e io non riuscivo più a capirla la filosofia teoretica, una discussione tra il professore ed il suo assistente, il quale si domandava se, adesso io non ricordo se si trattasse di Leibniz o dell’Idealismo, se in quel caso, di quell’espressione che lui aveva appena illustrato, l’io si ipostatizzava. Questa frase mi ha fatto male, “Ma come”, dico, “questi qui stanno a pensare se l’io si ipostatizza e ci sono milioni di cadaveri sepolti sotto terra. E io ho visto Armando Sacchetta senza gamba, Vittorio Duca che è morto a Buchenwald, mio fratello che è precipitato in mare, è morto in mare, sei milioni di ebrei gassati, tutta l’Europa per aria, dicevo, le mamme con i bambini che non sapevano come fare ad entrare nella camera a gas…”, ho fatto tutto una carrellata. Che l’io si ipostatizzasse come dicevano loro, per me è stato un motivo d’aprire uno scenario spaventoso e di farmi rifiutare l’io che si ipostatizza. Poi ho fatto lo stesso i miei esami, benissimo, ho preso un bellissimo voto. Ecco, che lei mi ha chiesto cos’è stato il dopo Lager. Sono stati tutti questi episodi.
D: Ecco, ma gli amici, pesava molto il fatto di essere stata nel Lager?
Mariuccia: Ma no, guardi che noi abbiamo avuto degli amici, io ho visto anche la strage dei miei amici che sono andati in guerra, ne abbiamo persi molti. E’ quello che le ho già detto prima, ho avuto la sensazione di una frattura, di un mondo che prima era così e poi non poteva più essere così. Perché noi poi ci siamo sempre portati in mente anche il dolore per queste persone scomparse, questa gente che era giovane come noi e che è morta mentre noi eravamo vivi, ecco, c’è poco da dire. Certo che il mondo non è più stato come prima, non perché siamo stati nel Lager, ma per quello che è successo. Non poteva più essere uguale.
D: Dopo il Lager, non può più essere uguale?
Mariuccia: No, non si poteva più pensare, fare poesia, fare pittura, fare musica, fare filosofia allo stesso modo.
D: Questo è un pezzo che dice Adorno, eh?
Mariuccia: Può darsi che sia anche detto da Adorno. Salvo poi recuperare i vecchi valori in una maniera diversa, inserirli in una maniera diversa nella società, non so come spiegarmi, non più come pura e semplice cultura ma come supporto per la fondazione di un mondo un po’ meno circondato da filo spinato, io non sono mai stata capace d’odiare. Non ho odiato mai nessuno. Una cosa che mi ha insegnato ad odiare è stato il Lager, io posso dire che ho imparato a odiare nel Lager. Io ho imparato a odiare i tedeschi, ho imparato a odiare i torturatori, gli ucraini, i violenti. Ho imparato a odiare lì, perché non sopportavo la crudeltà che vedevo esercitare. Questa è una cosa che nasceva dal mio carattere. L’odio verso la crudeltà, il senso di compassione che forse è anche una cosa che mi sminuisce come persona, mi impoverisce. Io credo che non sia vero, però. Però io nel Lager ho imparato a odiare. Non sono più stata capace di non odiare le cose che secondo me non erano giuste. E quindi quando anche adesso vedo un atto di violenza gratuita, anche un atto di violenza verso un animale, un comportamento disumano verso qualcuno, verso qualche cosa, io mi emoziono, mi imbestialisco, e intervengo. Tanto che mio marito mi dice, “Ma stai calma, ma cosa fai? Ma no, ma stai zitta”. “Ma come devo stare zitta? Non sai che il mondo va male perché tutti stanno zitti? Se tutti parlassero e dicessero quando è il momento giusto”. Mi è venuta in mente una riflessione molto profonda che fa il Manzoni nel suo romanzo, quando parla dell’uomo perseguitato e dice che il persecutore è doppiamente colpevole, perché perseguita un altro e suscita nel perseguitato dei sentimenti di odio.