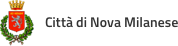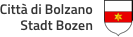Nota sulla trascrizione della testimonianza:
L’intervista è stata trascritta letteralmente. Il nostro intervento si è limitato all’inserimento dei segni di punteggiatura e all’eliminazione di alcune parole o frasi incomplete e/o di ripetizioni.
D.: Ci dice come si chiama, quando è nato?
R: Io sono Raimondo Ricci, sono nato nell’aprile del 1921; ho compiuto 79 anni e la mia vicenda relativa alla deportazione ha delle origini non immediate rispetto al periodo in cui sono stato deportato: sono entrato nel movimento antifascista, cioè ho preso delle posizioni antifasciste ed ho cominciato quella che allora chiamavamo la “cospirazione” quando ero studente universitario alla scuola normale superiore di Pisa, esattamente nell’anno 1939-1941, cioè da quando ho vinto il concorso nel settembre del 1939 a quando sono stato richiamato sotto le armi. Nella seconda metà del 1941 ho finito il corso di allievo ufficiale all’accademia navale di Livorno e sono stato designato, nominato ufficiale di marina. Come ufficiale di marina ho potuto scegliere la destinazione e l’ho scelta – nel frattempo mio padre, che era magistrato, era morto in Africa – nel comando di Imperia, la mia città di origine e anche già durante il periodo militare ho continuato ad avere rapporti in qualche modo anche progettuali ed organizzativi ma, in una forma ancora abbastanza informe con gli amici che avevo sia a Pisa, Genova e Imperia avevo e che appartenevano al movimento antifascista.
L’8 settembre del 1943, dopo un lungo periodo di servizio militare come ufficiale, allora ero addetto all’ufficio cifra del mio comando – io ho potuto seguire l’occupazione da parte dei tedeschi del comando marina di Genova; poi il 9 settembre ho visto i tedeschi del comando marina di Genova arrivare ad Imperia perché da Genova sono venuti dalla riviera di ponente per completare l’occupazione.
Nel frattempo da ponente, diciamo dalla Francia affluivano tutti quanti i militari sbandati dell’esercito italiano, che si era in gran parte dissolto, anche se poi c’erano stati episodi di resistenza di coloro che non avevano voluto cedere le armi, quindi anche qualche scontro a fuoco ma nella grande generalità il motto imperante era, come è noto, “tutti a casa”. Questo anche e soprattutto perché erano mancati gli ordini, era mancata l’organizzazione di una qualsiasi previsione di difesa rispetto alla ben prevedibile occupazione tedesca quando si fosse da parte italiana annunciato l’armistizio; quindi vi fu quella specie di fuga dalle proprie responsabilità del Re, di Badoglio e di tutto quanto lo staff dei militari italiani e di casa Savoia, che è ben noto e consegnato – anche in un modo abbastanza sconcertante – alla storia del nostro Paese.
Fin dai giorni immediatamente successivi al 9 settembre del 1943 io mi sono dedicato a sperimentare la possibilità – naturalmente insieme a tanti altri amici – di organizzare un movimento di resistenza armata all’occupazione tedesca. Il fascismo di Salò non era ancora sorto: cominciò a segnare la propria esistenza nel mese di novembre; il nostro nemico era sostanzialmente il tedesco occupante, il quale faceva già sfoggio dei propri metodi, che del resto i militari italiani avevano conosciuto anche quando avevano combattuto fianco a fianco con i tedeschi. Io insieme ad altri amici, in particolare ad Imperia, dove ho operato, ci siamo impossessati di armi, di qualche mezzo meccanico, l’abbiamo portato in montagna e di lì è nato il primo lavoro molto faticoso: era un lavoro che sembrava promettere una possibilità di organizzazione e poi invece magari deludeva questa prospettiva per poi rialimentare la speranza di riuscirvi, di organizzazione delle prime non ancora formazioni vere e proprie ma chiamiamole “bande” – così del resto si chiamavano nel gergo comune –“bande armate della Resistenza”.
A metà dicembre del 1943, praticamente tre mesi dopo circa l’inizio di questa attività e dopo l’armistizio io ebbi l’incarico, dato che avevo anche assunto una responsabilità di commissario in una banda partigiana, di recarmi a Genova per prendere dei contatti con il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria che, a sua volta, era via via in fase di organizzazione.
Stetti a Genova, cercai di partire in treno il più riservatamente possibile e tuttavia fui segnalato da qualcuno che riferì di questo mio spostamento – la mia presenza in montagna era ormai nota. Mi fu fatta la posta per tre giorni, tre giorni mi fermai a Genova e la sera del terzo giorno quando dalla stazione ferroviaria di Imperia e porto Maurizio, di sera inoltrata mi recavo in bicicletta, verso l’interno per ritornare in montagna, fui fermato da militari armati – chiamiamoli così – dell’UPI, cioè ufficio politico investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana, che nel frattempo si era costituita. Venni arrestato insieme a mia sorella, che mi era venuta a prendere alla stazione, mia sorella fu detenuta per tre, quattro giorni e poi lasciata libera. Io invece venni sottoposto a pressanti interrogatori perché si voleva sapere da me evidentemente l’organizzazione armata a che punto era e così via. Per fortuna – dico per fortuna per me – non c’erano ancora stati scontri particolarmente accesi e c’erano state però molte azioni d’impossessamento di armi, vettovaglie e tutto quanto serviva all’organizzazione logistica delle formazioni che andavano costituendosi; fui pestato a sangue e non torturato perché c’è una bella differenza tra l’essere picchiato e l’essere torturato e fui detenuto ad Imperia abbastanza a lungo, cioè fino al febbraio del 1944; quindi stetti ad Imperia quasi due mesi e nel frattempo il movimento partigiano, che io avevo lasciato forzatamente a seguito del mio arresto andava avanti, si organizzava.
La provincia di Imperia è stata la provincia che ha partecipato fortemente alla lotta di Resistenza: vi furono i primi morti, vi furono i primi combattimenti e nel febbraio del 1944 avemmo la notizia del combattimento di Alto, sopra Albenga, in cui fu coinvolto uno dei nostri più bravi, più valorosi e prestigiosi comandanti, Felice Cascione, che diede poi il nome ad una divisione garibaldina, la divisione Cascione. Ebbi notizia in carcere di questo combattimento con i tedeschi appoggiati da armati appartenenti alla Repubblica di Salò e dell’uccisione di Felice Cascione, un giovane medico di qualche anno più vecchio di me, ma un giovane particolarmente prestigioso, grande sportivo, grande figura anche morale nella Resistenza impierese e nazionale; motivo questo di profonda amarezza e di profondo dolore.
Proprio in quel periodo, subito dopo, i fascisti mi consegnarono alla Gestapo.
Venni trasferito nel carcere di Savona dove stetti diverso tempo e successivamente fui trasferito ancora nelle mani delle SS; attraversai un lungo periodo di detenzione nelle carceri di Imperia, esattamente nella IV sezione delle carceri di Marassi, che era quella proprio organizzata ed a disposizione delle SS dove comandava il comandante del servizio di polizia di sicurezza nazista di tutta la Liguria, che aveva sede a Genova, cioè quel tenente colonnello delle SS Siegfried Engel, che, con una sentenza abbastanza recente del 15 novembre 1999, quindi pochi mesi fa, è stato condannato all’ergastolo per le responsabilità che ha avuto in quattro grandi eccidi compiuti nei dintorni di Genova.
Venni arrestato, voglio dire trascorsi questo periodo di detenzione nel carcere di Marassi fino a quando agli inizi, nei primi giorni del giugno 1944 fui trasferito insieme ad altri detenuti, a tanti compagni, tra cui uno dei massimi dirigenti del partito d’azione, l’avvocato Eros Lanfranco, ed altri amici carissimi come il commercialista di grande cultura, Franco Antolini, mio amico fraterno anche se di qualche anno più vecchio di me. Insieme a tanti altri venimmo trasferiti in campo di smistamento di Fossoli di Carpi – il campo di Bolzano non aveva ancora cominciato a funzionare in quell’epoca – e poi successivamente, a metà giugno del 1944 venni in vagone piombato trasferito nel campo di eliminazione di Mauthausen, e di qui cominciò la mia esperienza di deportato.
D.: Le volevo chiedere, si ricorda il suo numero di Fossoli?
R.: No.
D.: Si ricorda se assieme a lei nel campo di Fossoli c’erano anche dei religiosi?
R.: Mi pare di sì. Io a Fossoli non stetti molto, meno di quindici giorni, stetti una decina di giorni. Vi incontrai degli amici di Imperia che erano stati mandati là prima di me perché erano stati in un primo momento arrestati poi liberati poi riacciuffati da parte dei fascisti e dei tedeschi. Lo so che c’erano dei religiosi sicuramente. Uno, di cui divenni poi fraternamente amico, e che condivise l’esperienza della deportazione è stato don Andrea Gaggero. Quindi don Gaggero è stato uno degli uomini che hanno più fortemente testimoniato l’esperienza della deportazione e quindi don Gaggero era con noi. I religiosi furono numerosi.
D.: Il viaggio di trasferimento da Fossoli a Mauthausen come se lo ricorda?
R.: Ma, dunque io questo viaggio di trasferimento lo ricordo come un viaggio estremamente faticoso e l’idea dominante fu quella però di vedere se riuscivamo ad organizzare e realizzare la fuga. Nello stesso vagone dove io mi trovavo vi fu l’organizzazione di un tentativo di fuga che solo in parte riuscì. L’organizzammo nel senso che uno di noi, che io non conoscevo precedentemente, piuttosto magro ma estremamente deciso progettò e poi realizzò nel corso del viaggio d’infilarsi nel piccolo finestrino che era chiuso da filo spinato, diciamo spostando, questo sbarramento di filo spinato, portarsi dalla parte esterna del vagone e poi attaccandosi alle sporgenze del vagone stesso riuscire a ribaltare la chiusura a gancio calante dall’alto che quindi poteva essere ribaltata. Riuscimmo, riuscì con questa manovra lui stesso a gettarsi fuori perché era riuscito ad uscire dal finestrino ma con grandi sforzi e con l’aiuto naturalmente di coloro che erano all’interno e poi ad aprire di un breve spiraglio la porta, appunto operando dall’esterno in modo da consentire a tre di noi di fuggire. Il tentativo di fuga degli altri, io dovevo essere il quinto a prendere il via, non fu più possibile perché il treno arrivò in una stazione; si fermò, le SS si accorsero di ciò che era avvenuto, chiusero ermeticamente il finestrino e si diedero anche alla caccia di coloro che erano fuggiti, per fortuna senza essere riusciti a riprenderli. Comunque si scatenarono anche contro di noi; non vi furono lì per lì delle esecuzioni, ma insomma cominciò quell’operazione di terrore che ha poi accompagnato tutta quanta la nostra vita nei tempi successivi.
Io posso dire che durante questo avvicinamento a Mauthausen, non sapevamo, quale sarebbe stata la nostra sorte poichè ignoravamo tutto, io almeno ignoravo tutto ed anche i miei compagni ignoravano tutto. Ci scherzavamo persino sopra: qual era nei campi il sistema di eliminazione, come i tedeschi, i nazisti l’avessero organizzato e sapevamo che andavamo in una destinazione che il fatto stesso che era ignota apriva la nostra possibilità, il nostro destino ad ogni possibile soluzione ma non eravamo assolutamente informati di ciò che sarebbe avvenuto.
Siamo arrivati a Mauthausen, come normalmente avveniva per i trasporti, di notte. Era una notte calda perché eravamo come ho detto alla metà di giugno e con le nostre povere suppellettili, le nostre valigie con quel poco che eravamo riusciti a trasportare, un po’ di effetti personali, un po’ di cibo, qualche marco tedesco in tasca, che le famiglie erano riuscite a farci avere attraverso il filo spinato di fossili, che non era del tutto impenetrabile. La mia unica sorella – i miei erano morti tutti e due – venne a trovarmi e mi diede un aiuto sia in cibo, perché io avevo ormai cominciato a soffrire la fame durante il carcere, e mi fece avere questi generi di conforto e anche un po’ di marchi tedeschi che avrebbero potuto servire.
La realtà è che arrivati a Mauthausen ci trovammo in un mondo non preventivamente immaginato. Io ho sempre considerato molto difficile raccontare l’esperienza dei campi di eliminazione e quindi anche la mia esperienza personale perché il mondo nel quale venimmo a trovarci era un mondo talmente diverso sotto mille profili da quello che potevamo immaginare o da quello che avevamo vissuto; pur nelle sue privazioni, nelle sue violenze e nelle sue sofferenze, ho sempre pensato che raccontare del campo di eliminazione fosse come raccontare l’esperienza di Marte agli abitanti della terra: siccome gli abitanti della terra non hanno mai conosciuto né potuto immaginare quale fosse l’ambiente di Marte era difficile riuscire a realizzare una comunicazione ed una comprensione reale della situazione in cui venimmo a trovarci. Posso tentare di dare qualche elemento.
Noi arrivammo di notte, fummo concentrati nella parte del lager che era destinata proprio ai trasporti in arrivo, era la prima parte della notte e progressivamente con il passare delle ore venimmo privati via via di tutto. Ci vennero portate via progressivamente le valigie, quelli di noi che le avevano, gli abiti, ci fu ordinato di toglierci gli abiti e poi via via, tutto quanto avevamo. Questa progressiva spoliazione, che veniva fatta su ordini delle SS un po’ da lontano, ma soprattutto dei kapò o di altri internati, i quali erano delegati a questa funzione, continuò fino al momento in cui si realizzò il solito rituale di accoglimento – che è diventato il solito quando lo abbiamo poi conosciuto – che era un rituale attraverso cui il sistema concentrazionario nazista dei campi di eliminazione ed anche di sterminio tendeva ad annullare completamente la personalità degli individui. Insomma l’attacco, io ho sempre pensato che il sistema era studiato scientificamente perché poi questo rituale era uguale per tutti i campi. I campi che furono installati in Germania, soprattutto nel corso della guerra, furono ben 1.200 circa, forse più perché alcuni vennero distrutti e se ne persero le tracce. Quindi un numero enorme. L’obiettivo era quello di ottenere prima l’annullamento della personalità degli individui cioè degli etfling, cioè dei prigionieri, degli internati che non erano prigionieri di guerra, che non erano detenuti – diciamo come uno normalmente detenuto per aver commesso un crimine – erano soltanto dei segregati destinati all’eliminazione. Se appartenenti poi a determinate categorie, per esempio alla razza ebraica, addirittura allo sterminio programmato. Possiamo interrompere un attimo?
Quando possiamo riprendere me lo dice.
Prego.
E questo rituale consisteva nella spoliazione completa, anche di tutti gli indumenti anche più intimi, quindi nella nudità assoluta; eravamo tutti uomini, nel transport di cui facevo parte non c’erano donne. Ma il trattamento che veniva riserbato alle donne, che venne riservato anche a Mauthausen. Mauthausen fu un campo nel quale le donne affluirono solo nella fase finale perché fu uno degli ultimi campi, se non l’ultimo campo, ad essere liberato. Il trattamento anche per le donne era lo stesso. Quindi denudati completamente e poi avviati alle docce; per noi furono effettivamente docce di acqua caldissima, di acqua bollente prima e di acqua fredda dopo e alla depilazione completa di ogni parte del corpo, quindi dei capelli, della testa, del pube e di tutto quanto il corpo. Quando uscivamo da queste docce, voi sapete bene che nell’ esperienza dei campi soprattutto, ma anche a Mauthausen c’erano le camere a gas; ma soprattutto di quelli che furono costituiti appositamente per lo sterminio degli ebrei e degli altri oppositori e quindi quelli in cui lo sterminio aveva dimensioni più massicce e di quelle che furono realizzate nei campi organizzati in una prima fase, a cui Mauthausen apparteneva.
Ma la questione non era tanto metodologica quanto quantitativa: c’erano delle grandi stanze che sembravano delle docce ed invece erano delle camere a gas, e dai tubi usciva il gas venefico anziché l’acqua come nel caso nostro. Anche a Mauthausen c’era questa situazione che però non era di normale funzionamento nei confronti dei trasporti ma perché venisse realizzato dovevano esserci determinate condizioni che poi per molti internati si verificarono anche a Mauthausen.
Dopo tutto questo noi eravamo praticamente come dei vermi. Naturalmente questo trattamento era particolarmente scioccante perché la spoliazione completa, questo trattamento di depilazione assoluta, queste docce calde e fredde, la distribuzione di indumenti che erano dei pantaloni e camicie a strisce bianche e blu verticali che venivano distribuite assolutamente in modo casuale senza alcun riferimento alle dimensioni di ciascun individuo, per cui qualche aggiustamento si poteva fare soltanto tra di noi scambiandocele quando un indumento troppo stretto era capitato ad una persona troppo alta, troppo grassa, troppo grande o viceversa e tutto questo creava una situazione di sgomento, era come un gran pugno nello stomaco dal quale non era facile riaversi. Noi abbiamo cercato, direi un po’ tutti di tenerci alto il morale l’uno con l’altro, eravamo italiani per fortuna tutti insieme almeno in quella prima fase. Però questo era la prima accoglienza alla quale si univa lo spettacolo, in particolare a Mauthausen: lo spettacolo era a sua volta molto scioccante perché Mauthausen ha l’aspetto di una grande fortezza medioevale. Occorre ricordare ma noi non lo sapevamo allora, io stesso queste cose le ho sapute dopo la liberazione; ecco perché la nostra memoria deve anche essere elaborata successivamente al momento in cui noi abbiamo vissuto determinate esperienze.
Mauthausen era sorto, sulla collina sulla quale era stato edificato a tre, quattro chilometri dal paesino di Mauthausen appunto, perché lì c’era una grande cava di pietre, di pietra particolarmente pregiata, molto dura e consistente di pietra scura che era divenuta per acquisto fatto proprio di proprietà delle SS.
Le SS erano un’organizzazione, è nota come la milizia al servizio totale e indiscutibile del Fuhrer – di Hitler – comandata dal reich Fuhrer delle SS, Himmler; fin dalla nascita legata però da un patto di morte con il Fuhrer della Germania, del popolo tedesco, cioè Adolph Hitler. Questa milizia, legata da questo patto cadaverico al suo conduttore ed al capo del popolo divenne ad un certo momento un vero Stato nello Stato, uno Stato dentro il Terzo Reich, uno Stato che aveva poteri assoluti su tutti i cittadini tedeschi, non parliamo poi sugli abitanti degli altri paesi che venivano via via invasi dalla Germania e quindi un potere di vita e di morte. Io arrivo a dire questo che non si può capire l’essenza, e le SS erano la quinta essenza del sistema nazista come sistema di potere, non si può capire se non si acquisisce questa consapevolezza: il nazismo concepiva il proprio potere come un poter assoluto e indiscutibile di cui a nessuno si sarebbe dovuto rendere conto sulla vita degli altri; il potere assoluto di vita e di morte. E le SS, gli appartenenti alle SS erano i depositari di questo potere a assoluto che discendeva loro direttamente dal loro grande capo, il Fuhrer della Germania e del popolo tedesco.
Il sistema concentrazionario al quale Mauthausen apparteneva era una delle espressioni dirette di questo sistema di potere che avrebbe dovuto essere il modello attraverso cui si esprimevano i grandi privilegi della razza superiore, la razza ariana, come ben sappiamo; e nella razza ariana il popolo tedesco come popolo destinato a dominare il mondo. Una concezione che aveva anche quella base ideologica che via via fu creata dagli ideologi del Terzo Reich perché c’era questa concezione che sapeva anche di tradizione barbarica, come è noto; e difatti confluiscono tutti questi elementi nel progetto di dominio fondato su una superiorità di razza e sul diritto di eliminazione delle razze ritenute inferiori o dannose, come gli ebrei, rispetto ai grandi destini del popolo tedesco o delle altre razze che erano destinate comunque ad essere ridotte in schiavitù o soggiogate dal potere della razza dominante. Questa era la concezione di cui i campi di eliminazione tra cui Mauthausen, erano non gli unici ma fondamentali strumenti di attuazione.
D.: Senatore, si ricorda quando è stato immatricolato lei a Mauthausen?
R: Certo, noi fummo immatricolati, io non mi ricordo nemmeno la matricola 41 mila e tanti, ma i numeri di matricola erano assegnati riassegnandoci i numeri dei morti insomma, quindi diciamo il numero di matricola in sè.. Io ho i documenti a casa con il numero di matricola però adesso in questo momento a memoria non lo ricordo. L’immatricolazione avvenne immediatamente. Ci fu assegnato un numero che dovevamo poi portare sulla nostra cosa, non ci venne a Mauthausen tatuato come in altri campi avvenne sulle braccia o sulle mani però l’immatricolazione avvenne il giorno successivo a quello del nostro arrivo, quando cioè fummo destinati al blocco di quarantena. Io fui destinato alla baracca 17; adesso nel campo di Mauthausen la baracca 17 non esiste più perché è stata demolita; sono state conservate soltanto alcune baracche esempio nel campo di Mauthausen, del così detto campo di quarantena.
Perché Mauthausen era una grande centrale di un sistema di circa 40 campi dipendenti, campi satelliti per così dire. Quindi Mauthausen, significa non il solo campo di Mauthausen, ma significa altri 40 campi. Lo stesso sistema vale per Dachau, vale per Buchenwald vale per tutti gli altri campi che vennero via via costituiti successivamente. Ecco perché la dilatazione enorme del numero dei campi alcuni dei quali avevano molti prigionieri, altri erano fatti anche da piccole unità di prigionieri.
Il sistema della quarantena, dunque anche durante la quarantena fummo destinati a lavorare. Io lavorai per giorni e giorni di seguito alla cava di pietra, un luogo terrificante di morte: era il luogo nel quale, quando si volevano eliminare un certo numero di individui, questi venivano mandati sotto le scudisciate delle SS e di kapò su per i centottantasei gradini della scala con dei carichi di pietra sulle spalle, carichi che potevamo scegliere noi quando non eravamo destinati all’eliminazione; ma se qualcuno un gruppo era destinato all’eliminazione, venivano scelti dagli aguzzini, chiamiamoli così, dai capi, i quali caricavano i prigionieri anche in rapporto alle loro forze di carichi superiori a quelli che avrebbero potuto portare sulle proprie spalle per centottantasei gradini. Allora i prigionieri naturalmente non ce la facevano, cadevano, venivano colpiti dagli aguzzini con i bastoni di gomma, con gli scudisci, venivano colpiti con i calci dei fucili delle SS che seguivano e poi venivano uccisi; e questa scala fu un luogo nel quale venne uccisa moltissima gente.
Io ricordo che nel luglio del 1944, prima di andare in trasporto in un campo dipendente, come adesso dirò tra un attimo, vidi lungo quella scala che veniva proprio percorsa dagli ex ufficiali, dagli ufficiali e sottoufficiali tedeschi che erano stati coinvolti nell’attentato a Hitler nel luglio ’44 in cui Hitler rischiò di perdere la vita ed invece gli furono bruciati solo i pantaloni, quello che avvenne nel suo bunker sul fronte orientale, vennero in gran parte inviati nel campo di Mauthausen ed erano proprio in un blocco vicino al nostro, vicino al blocco 17 dove io ero ristretto. Costoro dovevano essere destinati all’eliminazione ed io li vidi lungo quella scala caricati di quelle pietre e poi mitragliati dall’alto con fotografie che mostravano tentativi di fuga perché i tedeschi avevano anche cura di cercare di operare le messe in scena nelle quali erano maestri. Avevano già fatto la messa in scena dell’aggressione alla Polonia fingendo un attacco dei polacchi nei confronti delle loro postazioni di confine, avevano fatto la grande mistificazione dell’incendio del Terzo Reich attribuito ai dirigenti e sindacalisti socialdemocratici e comunisti nel 1933 e quindi erano maestri di mistificazioni di questo tipo.
E anche lì si tentò di rappresentare la fuga di questi poveri, diciamo valorosi militari che avevano avuto il coraggio di ribellarsi ad Hitler e di organizzare il tentativo di sbarrare la sua strada verso la distruzione del mondo e della stessa Germania. Comunque questa cava fu un luogo di tortura e badate qui c’è una contraddizione terribile alla quale io ho sempre pensato, che in qualche modo non ho risolto. Era un luogo nel quale si sono eliminate decine e decine di migliaia di persone ma in genere il campo di Mauthausen e la cava in particolare ancor più che la camera a gas, era un luogo in cui veniva tratto dalle SS un ritorno economico perché le pietre che venivano tratte da questa cava furono quelle che servirono per edificare questo campo sulla collina e dargli quell’aspetto di fortezza medioevale sulla quale campeggiava il famoso motto “Arbeit macht frei” “il lavoro rende liberi” e poi per esportare e per inviare questo materiale. Questa pietra sezionata a Berlino per essere utilizzata in quelle costruzioni, in quei progetti architettonici che erano uno dei sogni di grandezza di Hitler: Hitler si occupò sempre molto di architettura e pensò sempre ad un’architettura che tramandasse il suo grande disegno che avrebbe dovuto avere durata millenaria nel tempo consegnarlo anche i grandi edifici e le grandi realizzazioni simboliche che dovevano configurare architettonicamente la stessa faccia del Terzo Reich.
Ad un certo punto del luglio del 1944 venni inviato in un campo dipendente a Großramming vi arrivai con un gruppo che era di circa duecento, trecento e tanti italiani – con me vi erano l’avvocato Elio Lanfranco, di cui ho parlato prima, vi erano il povero Mino Steiner di Milano, vi erano altri amici della deportazione – e venimmo trasferiti in questo campo di Großramming dove fummo adibiti alla costruzione di una centrale idroelettrica. Quindi lavoro all’aperto, lavoro molto duro sotto il sole per quel primo periodo; il campo era un campo relativamente piccolo, meno di 1.500 internati. Facile era la previsione del nostro destino se fossimo rimasti a lavorare in questo campo anch’esso governato secondo gli stessi sistemi che venivano attuati in tutti i campi di eliminazione. Poco cibo, un cibo assolutamente inadeguato a contrastare la fame e la fame acuta diventava fame endemica, cioè una fame non più saziabile perché derivante da un assoluto deperimento organico e non dalla mancanza di cibo per uno o più giorni o anche da più settimane ma proprio da un decadimento dell’intero fisico; i prigionieri che via via diventavano larve, diventavano esseri che molto spesso perdevano anche il dominio dei propri istinti e questo era uno degli scopi a cui tendeva il sistema concentrazionario e quindi anche dal punto di vista lavorativo rendevano anche molto poco.
Ecco la contraddizione. Da un alto si volevano realizzare grandi progetti come quello della cava di pietra, come quello della centrale idroelettrica, come quello di tanti altri lavori attraverso lo sfruttamento del lavoro di questa massa di schiavi. E dall’altro lato si aveva nei confronti di questi schiavi che eravamo noi un trattamento tale da non consentirci neanche di conservare quelle forze che avrebbero reso il nostro lavoro più redditivo, e trattati in un modo tale per cui il nostro destino era inevitabilmente quello della morte, cioè quello della malattia, della consunzione, della morte per deperimento, la morte per i mille accidenti che possono capitare in una situazione di questo genere quando la situazione dominante è quella del terrore, dovuto alle mille insidie della nostra vita. Un terrore che a poco a poco nel tempo si affievolisce e poi la fame e il terrore, la fame e il terrore.
Noi vivevamo tra l’assillo della fame da un lato e le urla dei comandi che ci veniva gettati addosso in tedesco dall’altro lato ed i contatti che riuscivamo ad avere tra di noi, quel tanto di solidarietà che ci stringeva, che fu anche solidarietà molto intensa in alcuni momenti ma che non sempre era solidarietà, è inutile nasconderlo: le condizioni estreme nelle quali noi conservavamo la vita hanno fatto anche sì che nei campi molto spesso si verificarono anche delle situazioni non di solidarietà ma di contrasto, quando un pezzo di pane ed una gamella di zuppa potevano rappresentare un elemento di sopravvivenza. Rubare il pezzo di pane o impossessarsi della gamella diventava un qualche cosa che era direttamente connesso con la possibilità di sopravvivere.
Io non so se dire qualcosa della mia esperienza diretta, sono sopravvissuto perché a Großramming il campo è stato smantellato ed è stato smantellato per fortuna il primo di settembre del 1944; quindi tutto il comando, tutto il gruppo di prigionieri di quel campo ritornò a Mauthausen, perché nei piani economici tedeschi la costruzione di quella centrale fu ritenuto un lavoro non prioritario rispetto alle necessità dell’economia bellica.
Questa fu una fortuna per noi perché se così non fosse avvenuto, ai primi freddi sicuramente la massima parte degli italiani … io stesso sarei stato tra quelli perché molto malconcio, nonostante avessi allora ventidue anni e quindi una certa capacità di resistere, quando si è così giovani; la nostra fine sarebbe stata inevitabile. Intanto perché le nazionalità arrivate per ultime non avevano trovato il loro incasellamento e quindi in qualche modo erano le più esposte alla decimazione per così dire, e quindi saremmo sicuramente morti nella grandissima maggioranza.
Il campo fu smantellato ai primi di settembre, non era ancora arrivato l’inverno; rimpatriammo a Mauthausen ed io da allora feci tutto quello che potei, quel poco che mi era possibile per andare ancora una volta in transport perché mi resi conto che un grande campo di trenta, quarantamila internati, come era Mauthausen, c’erano maggiori possibilità di sopravvivenza.
Io vidi tutto a Mauthausen, subii tutto, tutto: le torture, i pestaggi, il lavoro, vidi nella parte finale della mia esperienza le fosse dei cadaveri, che venivano riempite quando i forni crematori non erano più adeguati a bruciare i morti, nel senso che le morti si succedevano con un ritmo eccessivo.
Fui in qualche modo spettatore se non testimone diretto della rivolta del blocco 20, dove gli internati che ivi avevano un trattamento particolarmente offensivo e vessatorio, tentarono la rivolta e riuscirono a fuggire in seicento morendo al 99%, se ne salvarono 5 o 6, non di più. Vidi, subii tutto. Dovetti anche trasportare i cadaveri ma ebbi anche alcuni elementi di fortuna, come appunto può accadere in un grande campo.
Conosco bene lo spagnolo, per metà del mio sangue sono di origine sudamericana, mia madre era argentina ed ho avuto modo di conoscere degli spagnoli, soprattutto due fratelli, che mi hanno aiutato a salvarmi la vita. Nel senso che gli spagnoli erano una delle prime nazionalità che prima della guerra, o perlomeno all’inizio della guerra, non prima, furono concentrati a Mauthausen perché catturati nel cerchio di Dunquerque; “Perché?: una rapida spiegazione”.
Questi spagnoli erano reduci della guerra di Spagna, espatriati dalla Catalogna quando la Repubblica spagnola venne definitivamente sconfitta in Francia, dai francesi internati in campi di concentramento che si trovavano vicino alla costa atlantica. Quella parte della costa dove fu poi accerchiato l’esercito inglese, che si trovava presente nel territorio francese. Ecco perché rimasero, furono praticamente, caddero nelle mani dei tedeschi quando i tedeschi spinsero a mare gli inglesi e la vicenda di Dunquerque è nota.
Questi ex combattenti della guerra di Spagna, combattenti per la repubblica, per la libertà della Spagna, vennero offerti da Hitler a Franco e Franco non li volle. E allora Hitler li concentrò in vari campi ed in buonissima parte nel campo di Mauthausen.
Vi arrivarono e si dedicarono alla costruzione e all’ampliamento del campo, buona parte del campo fu costruita da loro. Subirono le loro perdite poi, via via che il campo si dilatò, nelle loro mani si trovarono tutti i servizi essenziali del campo: le lavanderie, le cucine, i servizi di barberia, quelli stessi che vennero a rasarci con i rasoi, a toglierci i peli dalla testa, dal pube, dalle ascelle, dappertutto, dal petto chi li aveva, erano spagnoli. Quindi i servizi del campo erano in mano loro e naturalmente questo possesso dei servizi consentiva loro di avere delle inevitabili posizioni di privilegio.
Devo dire la verità, tra loro c’era una fortissima solidarietà e gli spagnoli non si prestarono mai anche perché erano tutti combattenti della stessa guerra e quindi un grande spirito di fraternità ed anche di comunanza ideale li univa e quindi erano, molto forti. Nessuno di loro si prestò a quelle funzioni repressive e vessatorie che furono invece le funzioni attribuite ai kapò, che erano quelli che dominavano i blocchi, cioè le baracche, quelli che conducevano i gruppi al lavoro, che nella grandissima maggioranza erano dei triangoli verdi, cioè dei criminali comuni, criminali della peggiore specie che proprio per la loro capacità criminale governavano gli altri.
Ecco quando io ho parlato di Marte rispetto all’esperienza della terra, io non dico che in una situazione normale nel mondo in cui viviamo i migliori siano sempre al vertice ma perlomeno c’è una sorta di riconoscimento di ciò che dovrebbe essere il meglio al vertice, insomma, cioè si agisce sempre in nome di fini di carattere superiore o comunque la selezione dovrebbe, ed in molti casi lo è stato, una selezione positiva. Il mondo era completamente ribaltato cioè la selezione che consentiva di porre con assoluta potestà di dominio degli uomini a governare gli altri, ad ucciderli sempre naturalmente come emissari e longa manus delle SS, quindi su mandato delle SS, erano i peggiori.
Erano i criminali, erano coloro che avevano capacità di continuare a commettere crimini. Questa specie di ribaltamento di quello che dovrebbe essere l’ordine naturale delle cose è un qualcosa che bisogna vederlo, bisogna sperimentarlo per rendersi conto di cosa significhi. Il mondo alla rovescia per così dire.
Ecco perché la realtà dei campi non è facilmente comprensibile nella sua estrinsecazione e poi nella vita di ogni giorno. Questa è l’esperienza attraverso la quale sono passato. Ho avuto anche la fortuna di qualche italiano. Ho avuto un amico fin dal periodo di Imperia, un architetto, l’architetto Alberto Todros di Torino, quasi mio coetaneo, uno o due anni più di me, con il quale fummo deportati insieme; era un giovane molto aitante, molto simpatico, conosceva un po’ il tedesco, quando fu censito ed immatricolato gli si chiese cosa faceva e lui, non so esattamente cosa disse, ma insomma un’attività di carattere pratico ed allora venne destinato a dei lavori, a delle attività – perché tutti dovevano lavorare nel campo – che in qualche modo creava qualche situazione di maggiore possibilità di sopravvivenza.
Noi che eravamo studenti, io, per esempio, studente in legge, in giurisprudenza, ero fatalmente destinato come tanti altri giovani alla pala ed al piccone, quindi ai lavori di assoluta manovalanza, che erano quelli in cui si rischiava la propria esistenza.
Questo mio giovane amico ebbe la fortuna di entrare nelle grazie di un capo tedesco esclusivamente – di un capo di un comando importante – esclusivamente perché si era dimostrato capace, su sua richiesta, di tracciare determinate linee su di un quaderno dove questo capo, essendo a capo di un grande comando, il Baukommando, doveva scrivere le statistiche del lavoro giornaliero. Tramite questo amico Alberto, io ebbi tutta una serie di facilitazioni sia pure episodiche, sia pure momento per momento, che certamente mi aiutarono ad uscire vivo da questo inferno, anche se poi però la mia vita, proprio per il fatto di essere passato attraverso esperienze di ogni tipo fu molto condizionata dal caso, molto affidata alle circostanze casuali per le quali uno può vivere e morire proprio come getta i dadi su un tavolo verde.
D.: Senatore prima parlava di due fratelli spagnoli che l’hanno aiutata. In che modo?
R.: Dandomi qualche zuppa in più. In particolare in questo modo, e facendomi avere dei piatti di zuppa aggiuntivi rispetto a quella di rape del tutto acquosa e quindi assolutamente inconsistente, in cui si trovava qualche pezzo di carne in più. Essenzialmente in questo modo.
D.: Come si ricorda la liberazione di Mauthausen?
R.: Mauthausen venne liberata in due fasi successive. La liberazione ufficiale avvenne il 5 maggio del 1945, perché questa è la data in cui arrivarono gli americani in forze con le loro autoblinde, i loro carri armati al campo. Però le SS fin dal 2 maggio se ne erano andate ed avevano lasciato il campo nelle mani della polizia di Vienna. Quindi in un regime già meno vessatorio anche se la gente moriva ancor più di prima perché la denutrizione galoppava ed il campo, essendo diventato il punto dove erano affluiti dai campi circostanti o anche lontani, molti internati; erano arrivati ed anche grossi contingenti femminili, pullulava di gente in cerca di cibo.
Quindi la fame galoppava. I morti erano tanti ed aleggiava un’aria di decomposizione e di morte sopra questi campi. Noi ad un certo momento, dopo che le SS se ne andarono, riuscimmo a liberare il campo, a disattivare cioè il circuito elettrico, ad alta tensione nel filo spinato che circondava il campo e a impossessarci delle armi che erano all’armeria delle SS e poi anche in un’altra armeria, a distribuirle a coloro che erano in grado di cooperare con il comitato di liberazione del campo.
Perché lì c’era un comitato clandestino, che aveva funzionato anche nei periodi più bui, naturalmente estremamente segreto, che tuttavia era riuscito ad avere diciamo dei momenti organizzativi. Il fratello di Gian Carlo Pajetta, Giuliano Pajettta, faceva parte di questo comitato clandestino, quindi aveva una funzione, anche perché veniva riconosciuto a livello internazionale perchè nel campo c’erano – vi ho parlato degli spagnoli, ma c’erano anche molti superstiti, reduci, della guerra di Spagna e lui era uno di quelli.
Quindi il Comitato di Liberazione armò dei gruppi, delle squadre, alcune delle quali si posero in condizione di difendere il campo, perché c’era sempre il ritorno delle SS. I nazisti avevano il progetto di distruggere tutti i campi e questo progetto lo attuarono in molti casi, alcune volte li evacuarono, altre li distrussero.
Io credo che di molti campi si siano perse le tracce perché furono completamente distrutti. Naturalmente a Mauthausen non riuscì perché per uccidere decine e decine di migliaia di persone ci vuole tempo ed organizzazione e naturalmente mancavano il tempo e mancava l’organizzazione in questa fase convulsa del finale della guerra per fare un’operazione di queste dimensioni.
C’era in più anche da parte loro, finalmente, il bisogno di cercare di salvarsi e c’era anche e quindi si realizzò una situazione di questo tipo.
Feci parte di uno di questi gruppi ed il compito che mi venne assegnato, con il fucile a tracolla, o in mano o in braccio era quello di fare la guardia, anche di notte alle cucine, perché nel campo c’era ormai una torma di persone ridotte ad una vita puramente istintiva, quella condizione alla quale avrebbero voluto condurci i nazisti, proprio come uno dei loro elementi programmatici, il cui fine era quello di trovare cibo ad ogni costo.
Quindi se le cucine non fossero state presidiate sarebbero state invase e saccheggiate e questo avrebbe provocato ulteriori guai in una situazione nella quale il problema dell’alimentazione era diventato un problema drammatico. Quindi io feci armato la guardia alle cucine del campo di Mauthausen per impedirne il saccheggio.
Questo è il mio ricordo della liberazione del campo. Furono catturati alcuni dei capi nei dintorni da questi gruppi che si erano resi responsabili. Io ne vidi linciare sulla piazza alcuni. Io mi sono sempre rifiutato; nonostante tutto quello che ho subito avevo conservato tanta coscienza di me e senso di responsabilità per riuscire a comprendere nonostante tutte le sofferenze e tutta la fame che la via della ritorsione violenta era proprio quello che dovevamo cercare di evitare. Li vidi linciare, e quindi compresi le ragioni del linciaggio; era la naturale vendetta di chi aveva subito cose inenarrabili da parte di queste persone; molti riuscirono a farsi rendere prigionieri, non so bene quale sia stata la loro sorte. Quindi questo è il mio ricordo della liberazione del campo; so che subito dopo il comitato di liberazione del campo fu sottoposto anche a me; emanò un proclama a livello internazionale; perché vedete noi oggi parliamo tanto di Europa ma questi campi erano una riproduzione di unità europea perché c’erano tutte le nazionalità dell’Europa in cui il dominio nazista si era esteso; quindi in tutta Europa, direi fino al Caucaso o fino a Mosca e alla Norvegia; tutte queste nazionalità erano presenti nel campo. Direi che questa esperienza di unità europea nella sofferenza dell’annientamento e dell’eliminazione ha una grande (importanza).
- << scarica la testimonianza (293 KB – PDF)
- << Raimondo Ricci: testimonianza sonora (61′) (15 MB – MP3)