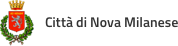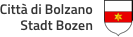Nota sulla trascrizione della testimonianza:
L’intervista è stata trascritta letteralmente. Il nostro intervento si è limitato all’inserimento dei segni di punteggiatura e all’eliminazione di alcune parole o frasi incomplete e/o di ripetizioni.
R: Buongiorno. Mi chiamo Milo Navasa, sono nato a Venezia il 27 maggio 1925. Figlio unico e abitavamo a Verona da parecchi anni. Mio papà lavorava alla Telve e io ero studente, scuole normali, liceo ecc.
Il 13 dicembre 1944 di notte abbiamo sentito un fracasso infernale giù alla porta d’ingresso della casa, hanno mezzo sfondato una porta ed era una pattuglia di SS. Sono venuti dentro, hanno beccato mio papà subito e stavano per portarlo via, quando girando per l’appartamento, sono capitati anche in camera mia che stavo dormendo, mi ero svegliato un po’ di soprassalto. Hanno chiesto a mio padre, il quale parlava tedesco tra l’altro e capiva, gli hanno chiesto chi ero e lui ha detto: “E’ mio figlio”. Hanno detto: “Komm” e mi hanno preso, anch’io.
Avevo diciannove anni, dunque non c’entravo un accidente, però mi hanno portato via. Ci hanno portato al sotterraneo delle SS qui in Corso Porta Nuova. Lì è cominciata la storiella. Mio padre è stato interrogato subito, io anche, però il mio interrogatorio si è risolto in una buffonata, perché allora io cascavo talmente dalle nuvole che evidentemente anche l’ufficiale che mi ha interrogato se n’è reso conto che non capivo niente, che non c’entravo un tubero. Siamo stati lì una quindicina di giorni mi pare, adesso ovviamente la memoria al giorno non ce l’ho più, ben inteso. Però un paio di settimane.
Dopodiché tutti e due ci hanno portato al Forte di San Leonardo, qua sopra Verona. Lì siamo stati due o tre settimane anche lì. Eravamo lì in carcere, avevamo un po’ di rancio, non avevamo uscite fuori, eravamo sempre dentro nella cella. Poi ci hanno trasferito al Forte di San Mattia, che è un altro forte qui di Verona, quello più alto. Anche lì tran/tran quotidiano, mio padre era fuori dalla grazia di Dio, io che non capivo cosa cavolo mi stesse succedendo. Un bel giorno ci tirano fuori tutti, ci imbarcano su un autocarro e ci portano su a Bolzano.
Mi sono ritrovato anch’io lì. Ci hanno messo nel blocco B, non sapevo niente praticamente, un po’ spaventato, un po’ tutto. Dopo due o tre giorni, adesso il giorno preciso non lo ricordo così, hanno fatto un appello e hanno chiamato assieme a tutti gli altri mio padre, non me.
Anzi, anche lì a Bolzano mi hanno fatto un altro interrogatorio così, che si è risolto in niente, una buffonata. Credo si siano accorti che non avevo le mani in pasta né con la Resistenza né con questo né con quell’altro, com’era vero infatti. Non ci pensavo. Hanno fatto l’appello, avranno chiamato due o trecento persone, fra le quali mio padre. Di fatti noi eravamo in piedi lì così e loro chiamati dovevano mettersi dall’altra parte del cortile allineati. Quello è stato l’ultimo giorno che ho visto mio padre, non ho più saputo niente là naturalmente.
Al primo maggio hanno aperto il campo, a gruppi di una trentina di persone ci hanno caricato su un autocarro che ci portava in giù. Lo sbarco, diciamo così, avveniva, l’ho saputo dopo, a paesi diversi. Hanno avuto probabilmente paura che mollando il campo di colpo ci fosse una reazione da parte nostra, perché penso saremo stati un migliaio, era affollatissimo. Allora probabilmente l’hanno fatto per questo scopo.
Allora a me hanno scaricato a Bronzolo, mi ricordo ancora. C’era tutta la retrovia tedesca che stava andando in su in ritirata, elmetti fin qua, mitra imbracciati, un inferno, qualche autoblinda ecc. Una strizza dell’accidente, però dico: “Devo andare a casa, è inutile che mi metta qua”.
Allora mi sono strappato via il distintivo, che avevamo il triangolo rosso. Tolto via quello ho cercato di apparire uno qualsiasi e ho cominciato a camminare. A camminare ci ho messo otto giorni, sono arrivato a Verona a piedi. Tra l’altro non è che avessi una gran forza, perché là sì, ci davano qualcosa da mangiare senz’altro, però non certo pasti.
Un pagnottino così al giorno. Poi tra l’altro quando ci hanno mollato avevamo già discusso tra noi che saremmo entrati in Bolzano a pescare il panettiere, perché queste pagnottelle, una al giorno, grandi così, si faceva così con le mani e strizzava fuori acqua. Pesava di più, perciò ci faceva pagare di più. Avevamo giurato di andare là e disfargli il forno. Invece, niente. Ci hanno mollato apposta, penso, per evitare rappresaglie probabilmente.
Mi ricordo ancora un episodio. Quando sono arrivato lì a Rovereto, c’era molta gente. Ad un certo momento mi vedo arrivare un carro armato in mezzo alla strada. “Porca boia”, dico, “ancora, madonna santa”. Un bestione che non finiva più. Allora va beh, mi sono messo ai margini della strada. Passerà anche questo. Ad un certo momento ha spalancato il portello di sopra, è uscito a mezzo busto un negrone, un bestione della madonna con due mani messe così. “Paisà” ha detto.
E giù sigarette in mezzo alla gente. Ho ringraziato il padreterno, “Dio ti ringrazio, qui ci sono gli americani, i primi che vengono su”. Dopo mi sono accorto che sul carro armato c’era una stella bianca dipinta, ma io non lo sapevo. Allora mi sono rilassato e ho fatto Rovereto Verona con più calma, perché ormai c’erano le truppe americane che venivano avanti e non mi facevano certo paura. Qualcuno aveva predisposto qualche posto di ristoro durante il campo e lì ho mangiato qualche minestra, ho dormito un po’ nei fienili. Sono arrivato a casa e mia madre era lì, ha visto arrivare me e non ha visto poi arrivare il mio vecchio.
Lui so che appunto è andato a Mauthausen e dopo l’hanno ammazzato, il giorno preciso non lo so, perché non sono riuscito a saperlo da nessuno. Sono andato appunto la settimana scorsa, sono andato là in pellegrinaggio perché per tutti questi anni non ho mai avuto il coraggio di andare su, non me la sono sentita. E’ da rimproverarmi, su questo d’accordo, lo capisco, ma non ce la facevo. Stavolta no, mi sono deciso, dico: “Vecchio mio”, perché quando mangio, tra l’altro, ho la fotografia del mio vecchio, ce l’ho davanti. Io sono da solo, ho la fotografia del mio vecchio e della mia vecchia davanti alla tavola della cucina, tutti e due, così che ce li ho lì tutto il giorno.
Allora dico al mio vecchio: “Stavolta vengo, stavolta vengo” e sono contento di essere andato, anche se sono ancora un po’ nei pasticci, non sono ancora uscito. La visita è stata una roba, come se mi avessero segato a pezzetti. Quello che non ho visto dentro… Mi figuro quei disgraziati cosa devono aver subito quando sono stati presi e portati lì dentro.
Ho visto i forni crematori. Hanno messo alcune fotografie che qualcuno ha fatto e ha salvato dalla distruzione, ingrandimenti così. Carri pieni di gente magra così, morti, mezzi morti e li stavano portando verso i forni. Ecco, per dire, roba del genere, sono uscito fuori da lì che ero fuori dalla grazia di Dio. Sono andato a vedere Gusen proprio e ho visto i forni crematori, ho visto le camere a gas, ho visto l’animassa che ti porta. Dopo pochi giorni fa ho visto Hayder seguito da folle osannanti e non vi dico cosa ho pensato, perché non è il caso, il turpiloquio non va bene.
D: Milo, scusa.
R: Dimmi.
D: Perché hanno arrestato il tuo babbo?
R: Adesso ti spiego questa cosa, che fa pensare proprio alla gente come può essere a volte. Mio papà con alcuni dei suoi coetanei, aveva quarantanove anni quando l’hanno preso, si erano buttati dentro, perché mio papà aveva fatto la Grande Guerra completamente dal primo all’ultimo giorno, per cui i tedeschi gli stavano qua e si era buttato nel Comitato di Liberazione.
Erano sette od otto che avevano fatto questo gruppetto, in casa non sapevamo niente e compagnia bella. Se non che si è infilato dentro uno italiano, il quale ha finto di essere dentro così e poi li ha denunciati tutti. Allora un giorno che ancora eravamo qui alle SS in Corso Porta Nuova ci hanno portato fuori a dare una mano, perché c’era il bombardamento, tirare via un po’ di macerie. Stavamo tutti e due andando insieme con gli altri, mio papà mi ha detto: “Ehi, Milo, attento. Guarda quello lì col cane. Guarda bene”. Io lo guardo bene, fissato, fotografato. “Quello è quello che ci ha fatto la cavalletta a tutti”. Quando sono tornato a casa l’ho cercato per un anno. Non so se avete visto quel film con Sordi, quando gli ammazzano il ragazzino, che poi va fino a che becca quello che…ecc… e’ “Un borghese piccolo piccolo”, mi pare che fosse. Faceva la stessa fine. Per un anno per tutte le strade ero lì che mi guardavo intorno, ma o era andato via o… Non l’ho più visto, non ho più saputo niente. Questa è la vecchia storia.
D: Quindi il tuo babbo faceva parte del gruppo…
R: Il Comitato di Liberazione di Verona.
D: Tu invece non sapevi nulla?
R: No, non sapevo niente. Ero un tataro qualsiasi, mio padre se n’è guardato bene dal parlarne a casa, perché altrimenti mia madre gli avrebbe fatto l’inferno. Allora in casa non sapevamo niente. Li hanno beccati tutti e sono crepati tutti, li conoscevo anch’io. Per fortuna hanno fatto un interrogatorio anche stringente, ma non potevo confessare, perché non avevo né fatto né pensato né niente. Ero un ragazzotto, uno stupidotto, non è che avessi delle mire a dire… Se ne sono probabilmente accorti e ne hanno tenuto conto forse, non so, perché non mi hanno cacciato in quel pasticcio, mi hanno lasciato lì fino alla fine della guerra.
D: Milo, cosa c’era su al Forte San Leonardo?
R: Niente, c’era un gruppo di SS e basta. Noi eravamo in una cella, qualche volta ci facevano prendere un po’ d’aria in alcuni passaggi che hanno lì dentro liberi. Nel forte non c’era niente, comandi, compagnia bella. Nemmeno in San Mattia. Prigioni erano, così. Ci hanno tolto dalla città e ci hanno messo là.
D: Quando vi hanno prelevato per partire per Bolzano, dove vi hanno caricato?
R: Eravamo al San Mattia, l’autocarro è venuto lì, ci ha fatto montare e poi è partito, siamo andati fin là.
D: Siete arrivati al campo di Bolzano?
R: Sì. Siamo arrivati direttamente al campo.
D: Eravate in tanti?
R: Parecchi. Non so dirti quanti, ma credo così adesso, la stima mia può essere…ma penso che dovessimo essere intorno al migliaio. Almeno credo. Io ero il numero 8.718, mio papà 8.717.
D: Durante il trasporto su a Bolzano il camion non si è mai fermato? Era un camion solo?
R: Un camion solo e basta, c’erano un paio di motociclisti, elmetto fin qua e basta. E’ andato via così.
D: Siete arrivati di sera su a Bolzano?
R: No, c’era ancora chiaro. Pomeriggio senz’altro, però c’era ancora chiaro. Ci hanno assegnato ai vari blocchi, io ero al blocco B, c’erano due grandi capannoni, erano separati per lettere, A, B, C, D, E, F era quello delle donne. Io sono stato al blocco B fino al momento che hanno aperto il campo.
D: L’immatricolazione lì a Bolzano ve l’hanno fatta subito?
R: Il giorno dopo credo, sì, sì, immediata. Col numero, triangolo rosso e il numero in bianco, 8.718.
D: Ti hanno tolto i tuoi vestiti?
R: No, mi hanno lasciato quegli stracci che avevo. In casa non mi hanno lasciato neanche vestire praticamente, ho infilato un paio di pantaloni e qualcosa addosso, basta. Non avevamo niente, così proprio… “Weg, weg, komm, komm” e basta. Insomma, fatti cosa, a dire: “Un momento”, no, no. Come adesso, fai conto.
D: Ascolta, dentro nel campo cosa ti ricordi? Altre persone, altri amici? Parlavi delle donne.
R: Sì, il blocco delle donne era appunto il blocco F. Alla mattina per esempio avevi il momento che potevi stare sul cortile, potevi stare anche fuori dai capannoni, nessuno ti rompeva le scatole. C’è stato un solo episodio di un ragazzo di Milano, che avevano mandato fuori una squadra per pulire un po’ di macerie ed era andato fuori anche lui. Dopo al ritorno non l’avevamo visto e abbiamo sentito, c’era una specie di fabbricato in fondo vicino ai blocchi nostri, e abbiamo sentito per un paio di giorni delle urla mica male. Deve avere preso una pestata. Di fatti poi è uscito, aveva segni dappertutto. Ma è stato l’unico episodio però che ho visto.
Lì a Bolzano non è successo niente, porco cane. Non è successo assolutamente niente angherie, violenza. Niente. Alla mattina sveglia presto, tutti fuori in cortile, cappelli giù, via, cappelli giù e il momento di salutare la guardia. Poi ti davano un po’ di sbobba, mezzogiorno ancora un po’ di sbobba, questo pagnocchino infernale e la sera qualcosa d’altro. Insomma, onestamente fosse stato solo Bolzano avrei detto: “Va beh, una vacanza andata male”. Non di più, sul serio.
Non immaginavo allora che i campi di là fossero tutt’altra cosa, capisci? Dopo l’ho saputo, caspita, quando sono tornato a casa, quando cominciava a tornare della gente, ho cominciato a leggere e ho cominciato a sentire. Dio Cristoforo, dico, ma com’è possibile? A Bolzano non è successo niente. Non hanno ammazzato nessuno, non hanno pestato nessuno e non hanno messo in croce nessuno. Guarda che ci ho fatto dentro un paio di mesi.
D: Ti ricordi se assieme a te nel campo di Bolzano c’erano anche dei religiosi?
R: Erano quelli più codardi di tutti noi messi assieme. Mi ricordo che c’erano un paio di frati, era uno, un frate di Via Barana. Quello era sempre a chiedere conforto, anche a me. Lui sarà stato più anziano di me, avrà avuto a quei tempi quarant’anni. Ero un ragazzetto così. “Oddio, Milo, cosa dici, che qua, che là…”. Ma dico, padre, a un certo momento, santo cielo, doveva essere lui che consola, porca di una miseria. “Ma qui, ma là, hai visto qua, hai visto là”. Tutti i giorni una balla di questo genere. Dopo lo schivavo come la peste perché non è possibile, Sant’iddio.
Uno qualsiasi può avere le sue idee, ma non un religioso. Doveva essere lui a confortare noi o dovevo essere io a diciannove anni che consolavo lui? Porca miseria, no scusa. Di fatti lo schivavo come la peste dopo. Tagliavo corto, gli dicevo: “Si, va bene”. Bon, andavo via.
D: Ti ricordi come si chiamava questo padre?
R: No, purtroppo… Ho cercato di ricordarlo ancora, ma non sono più stato capace di ricordare.
D: Ascolta, ti ricordi se c’erano, hai visto anche dei bambini, dei ragazzetti molto più giovani di te?
R: No. Io no. Direi che fossimo tutti adulti, penso.
D: Ti ricordi del blocco celle?
R: Al blocco celle non sono mai andato. Sì, c’era, è un fabbricato in fondo. Ci sono i due capannoni lunghi messi così con A, B, C, D ecc. e poi in fondo c’era un fabbricato laterale così, quello era solo per i tedeschi. Lì so che c’erano le celle, perché quel milanese lì l’hanno suonato lì dentro. Ma lì non hanno portato nessuno, è l’unico che hanno portato dentro nel periodo che sono stato lì io. Anche non potevi fare ribellioni di nessun genere, cosa volevi fare?
D: Ma parliamo dei due ucraini. Te li ricordi?
R: Sì. C’è stato recentemente qualcuno a Verona che mi ha chiamato per vedere, perché avevano recuperato sembrava una foto di questi ucraini. Dico, a cinquant’anni di distanza non ce la faccio mica. Però erano quelli addetti al pestaggio e anche nelle piccole cose, perché per esempio la mattina in adunata, chiamiamola così, se c’era da dar qualcosa sempre grintosi con le mani.
Poi se c’era da darti un calcione, quello te lo davano volentieri, perché magari un centimetro là non è che ti dice: “Weg, weg”. No, ti dava un calcione. Quella era proprio l’abitudine. Tutti e due giovani, questi figli di buona donna, erano quelli proprio addetti. Per fortuna la politica del campo non era quella, perché se appena appena avessero avuto un po’ di libertà con quei due lì venivano fuori giostre da mettersi le mani nei capelli. Appunto due o tre mesi fa mi hanno chiamato perché mi hanno fatto vedere. “Caspita”, dico, “strano che abbiate recuperato le fotografie adesso, è passato troppo tempo, non potrei”, dico. “Non posso, mi spiace”.
Dice: “Sa, abbiamo saputo che…”. “Sì, lo so, c’ero”. Proprio sarebbero stati i due addetti che se il comandante del campo fosse stato una carogna o avesse avuto ordini diversi, gli addetti erano loro due. Proprio ce l’avevano nel sangue, li vedevi da come si muovevano, da come facevano. Comunque non è successo, lì da noi non è successo niente.
D: Milo, ti ricordi che c’era una donna soprannominata “la Tigre”?
R: No. No perché lì al blocco F qualche volta ci avvicinavamo per chiacchierare un po’ con prudenza, perché non volevano mica. Sai, scrivevamo così e non so dirti come fosse o se c’era qualcuna in particolare. Erano là tutte ammucchiate in questo baraccone.
D: Milo, attorno al campo c’era un reticolato e c’erano delle sentinelle su delle garitte?
R: Sì, sì. Agli angoli del campo sì.
D: Ascolta, tu sei rimasto lì a Bolzano, nel Lager di Bolzano per diversi mesi?
R: Per lo meno guarda, fatti i conti adesso così, dei giorni ovviamente non riesco a fare il conto totale, ma penso di avere fatto un due mesi, due mesi e mezzo lì dentro. Fino al primo maggio.
D: Cosa facevate tutto il giorno dentro nel campo?
R: Niente. Non ci facevano lavorare. Eravamo lì, eravamo dentro nel nostro blocco a ciondolare, non ci hanno fatto lavorare. Qualche volta hanno preso qualcheduno a caso, lo portavano fuori, ma quando c’era qualche bombardamento magari che c’erano macerie da portare via. Così sporadico però, ma a noi come prassi del campo non ci facevano fare niente. Eravamo lì.
D: Ti ricordi qualche tuo compagno del blocco B, oltre al tuo babbo?
R: Sì, c’era Zanini che conoscevo ancora prima. Dopo, aspetta, chi c’era ancora… Accidenti, adesso dovrei fare un po’ mente locale, abbastanza difficile sai, perché di tempo ne è passato un fracco. Ricordo Zanini perché era il cosiddetto capo blocco nostro, era uno che teoricamente dava ordini a noi, va beh. Era un insegnante anche lui tra l’altro.
Dopo, un altro di Parma, un ragazzetto, Pietra, me lo ricordo ancora, un cognome stranissimo, Pietra. Ha detto: “Qui voglio scappare”. “Stai attento”, dico, “perché hai visto cos’è successo a quell’altro”. “Sì, ma io qua dentro non ci sto mica”. Avevamo fatto un po’ amicizia perché eravamo vicini di branda. Dopo, qualche altro, ma sai, è passato mezzo secolo.
D: Mentre voi del blocco B non siete mai usciti dal campo, altri uscivano dal campo per lavorare?
R: Sì, ti ho detto, qualche volta ma sporadicamente, molto poco. In generale era dopo i bombardamenti. Basta, ma non era che appunto fossero fuori per lavorare e tornare dentro alla sera, no. Episodi proprio, e basta, capisci? Magari volava una bomba, raccoglievano trenta o quaranta persone e le portavano fuori, davano una mano a pulire la strada, tirare via macerie e poi tornavano lì. Nessuno lavorava fuori dal campo di Bolzano, nessuno.
D: Ti ricordi se al campo, tu parlavi prima che avevate il triangolo rosso, c’erano altri triangoli di altri colori?
R: Triangolo giallo, che doveva essere quello degli ebrei se ben ricordo. Mi pare che fossero solo quei due colori lì. Mi pare però. Il rosso era teoricamente per loro per i politici, perciò era il nostro. Gli ebrei invece avevano il triangolo giallo, perché difatti hanno fatto un’infornata.
E pensa che dopo che hanno fatto la tradotta di mio padre, dopo dieci giorni circa hanno fatto una tradotta di ebrei, soli ebrei. Li abbiamo visti, eravamo in cortile, chiamati tutti, altre duecento persone o più. Li hanno portati, erano partiti, il giorno dopo sono tornati lì perché avevano già bombardato la linea gli americani. Da quel giorno lì hanno continuato a bombardare a Bolzano Brennero, non è più andato via nessuno. Se mio papà tardava un pelo, sarebbe ancora qui. Proprio l’ultima tradotta, porcaccia di una miseria, l’ultima. I disegni della Provvidenza sono quelli che sono, porco cane.
D: Milo, il gruppo di tuo padre ha lasciato il campo come?
R: Questo non lo so più, perché sono cose che sono avvenute dopo, io non lo so. A un certo momento li vedevi partire, tra l’altro sono morti dopo, dunque non so. Li chiamavano… Non so dirtelo questo proprio.
D: Non li hanno caricati su dei camion dal campo di Bolzano?
R: No, perché, vedi, l’ultima infornata è stata quella di mio padre e ho visto lui andare via così e basta. Non so con cosa l’abbiano portato là. Dopo non ho più visto niente, capisci? Hanno tentato qualcosa, ma non sono più riusciti a far niente, perché non potevano più. Le strade ormai erano impercorribili, perché gli americani avevano cominciato a fare sul serio, capisci? Sicché non so se li avevano portati con camion, boh. Sì, probabilmente con camion, senz’altro. Perché la distanza non è molta tra l’altro. Eri dentro, non sapevi niente.
D: Milo, durante il tuo periodo di deportazione a Bolzano tu, il babbo e gli altri compagni avevate avuto l’occasione di poter scrivere o di ricevere pacchi o posta?
R: Qualche tentativo c’è stato, ma arrivava il pacco, la carta e qualche pezzetto dentro, il resto tutto… Ti davano un cartoccetto così. Scrivere neanche a parlarne, c’è stato proprio silenzio fin quando sono tornato a casa.
D: Un’altra cosa, tu sapevi che dentro all’interno del campo di Bolzano c’era un gruppo di deportati che lavoravano per la Resistenza interna nel campo?
R: No, non te lo so dire. Anche perché io penso che sarebbe stato estremamente difficile, perché lì armi non ce n’erano ovviamente, avevi la casacchina indosso e basta. La branda era un cuccio messo lì col pagliericcio e basta, non avevi armadietti, non avevi un accidente, per cui non penso che potessero far qualcosa. Avere l’intenzione di fare senz’altro, però al lato pratico, praticamente non era possibile. Sarebbe stato come in un campo di nudisti, che vanno a scassinare casseforti. Con cosa? Con le unghie?
Per cui anche se c’era l’animo senz’altro, mi pare che c’era l’animo, ma non potevi attuare. Ogni tanto ti capitavano dentro al blocco, davano un’occhiata in giro qua e là, per cui sapevi benissimo che se ti beccavano con un pezzetto di ferro così la passavi brutta. Allora nessuno poi faceva niente. Intanto non sapevi chi te le poteva portare, perché i contatti con l’esterno… Da fuori cosa vuoi, che entrasse uno col pacchettino di roba nascosto nella tasca? No di sicuro. Per cui non c’era niente lì, eravamo così come sono io adesso.
D: Quando hai saputo della morte del tuo babbo?
R: Ce l’hanno comunicato…intanto, visto che non tornava, ho immaginato subito. Qualche mese dopo ci hanno dato la conferma ufficiale, morto a Gusen e basta. Si fermavano lì all’Adige, non mi ricordo più adesso il posto, un attimo… San Giorgio, che avevano messo fuori le fotografie di tutti quanti.
Avevano messo fuori la fotografia di mio papà, lì arrivavano dei deportati e allora si chiedeva, c’era tutta una specie di bacheca fatta così. Sono andato giù per dei mesi, fin quando si è diradato completamente il ritorno di gente, nessuno sapeva un tubo. Per cui quelli che erano con lui sono crepati con lui. La notizia precisa non l’ho avuta da nessuno, data presunta della morte e basta, niente di più.
D: Scusa, questo San Giorgio dov’è?
R: San Giorgio è in riva all’Adige. Qua a Verona, quando vieni, che so io, da Ponte Navi, tu costeggi l’Adige, ad un certo momento vieni verso borgo Trento, quella zona lì si chiama San Giorgio. Dove si aprono le strade per borgo Trento.
Lì arrivavano a volte camion di gente che era deportata là, lavoratori e compagnia bella arrivavano giù. Avevano messo…c’era un muro e avevano messo fotografie, dopo andavano là per sentire se qualcuno veniva dai campi di là. Ho fatto settimane lì, poi mi sono stufato perché capivo che non riuscivo a combinare niente, allora basta. Sono andato a sentire qualche notizia e le ho avute dopo dall’associazione.
E’ stato lì, è morto a Gusen, la data precisa non si sa ancora, perché lì facevano l’infornata, non è che tenessero conto. Probabilmente tenevano conto del numero giusto per fare un bilancio matematico, ma non di più. Adesso hanno pescato fuori sulla Gazzetta Ufficiale, la morte di mio papà col giorno, sarà vero, non sarà vero… Non lo so. Mi hanno dato un giorno, poco tempo dopo che l’avevano portato via, il giorno è risultato neanche due settimane dopo che era andato via da me.
Probabilmente sarà anche giusta, probabilmente qualche dato l’avranno trovato magari in mezzo alla fureria di questi campi, forse. Tanto lo spazio era ristretto, che fosse quella settimana o quella dopo non cambia niente, non è un anno di differenza. Purtroppo sono stati quei due mesi lì, quel mese e mezzo lì. Bastava un poco di niente e sarebbe tornato a casa anche lui, porca vacca. Scusate il termine.
D: Milo, quindi lì a San Giorgio non c’era un ufficio però?
R: No, era lo scalo di quelli che venivano giù da là. A Verona, magari portavano giù anche quelli che erano andati a lavorare, tante belle storie. Scaricavano giù lì a San Giorgio poi ognuno andava per i fatti suoi, non era una zona prestabilita. Era soltanto per abitudine, si andava lì, allora c’era sempre gente, si chiedeva, si faceva vedere la fotografia. “Per caso, eri là, hai visto qua?”. Sono andato avanti un sacco di tempo, dopo ho visto che non serviva a niente, ho smesso e si era rarefatto anche il movimento di gente che veniva in giù, ormai si era già scaricato il fiume grosso.
D: La tua Liberazione, come siete stati avvisati voi?
R: Niente, una mattina ci hanno chiamati fuori all’appello. Uno ha tradotto: “Adesso si esce dal campo, si esce a gruppi, ci sono gli autocarri che portano via”. Basta. Bene. Allora sono montato su uno degli autocarri e lì uno scaricava qua, uno di là, uno in là, uno in qua in modo da evitare l’afflusso, perché se la sono vista brutta in quel momento lì. Se la sono vista brutta veramente. Noi appena scaricati, chi si mette lì a raccogliere gente per tornare indietro? Figurati. Avevamo solo voglia di menare le tolle. Abbiamo incominciato a camminare in giù, c’era una fiumana di gente continua che andava in giù.
D: Era maggio dicevi, no?
R: primo maggio.
D: Tu sei ritornato da solo?
R: Sì.
D: A piedi?
R: Ho schivato completamente la compagnia per un semplice motivo, che quando eravamo sul mio camion, eravamo sull’autocarro scoperto, avevamo già incominciato a incrociare le prime retroguardie tedesche che venivano giù, c’è stato uno sciocco. C’è la signorina, non volevo dire la parola. “Adesso è finita, eh!”. Dio Cristoforo, come gli sono saltato addosso.
“Se muovi ancora un dito ti strangolo, cretino d’un cretino. Ma ti accorgi che sono ancora armati, hanno le armi impugnate in mano ancora, perdincibacco! Un gesto così ci sparano addosso, adesso che è finita, cretino”. “Non credevo, non credevo”. Si è messo lì in un angolo, non ha più sbuffato. Stavo strangolandolo, porca vacca. Va bene. Allora la discesa me la sono fatta per conto mio, dove c’era il gruppo o mi fermavo o andavo avanti o mi spostavo o mi sedevo da una parte della strada.
Niente, l’ho fatta tutta da solo. Almeno io vado via a testa bassa, basta. Quegli altri difatti non mi hanno mai rotto le scatole, sono andati su incavolati, perché in piena ritirata, figurati. Però perlomeno io non li ho stuzzicati. Quell’altro così gli ha fatto, madonna mia, mi aspettavo una raffica di mitra secca. Dico, crepare proprio adesso a guerra finita no ragazzi. Allora solo soletto, altri mi dicevano: “Vai giù anche tu?”. “No, no, mi fermo”. “Di dove sei tu?”. “Sono arrivato, sono qui”.
Tutto così, piano piano. Ho fatto tutta la Val d’Adige, conosco abbastanza bene la Val d’Adige. Sono centocinquanta chilometri, non è che fossi molto allenato, un po’ per la fame, un po’ per tutto, non è che fossi proprio in condizioni splendide. Però sono arrivato da mia madre, poveraccia. Era ridotta uno straccio. Mi ha visto arrivare dalla strada, perché era seduta sul poggiolo. Mi hanno detto che stava sul poggiolo delle ore tutti i giorni. Ad un certo momento: “Oddio, Miletto, oddio sei tu?”. “Sono io, sono io”. Allora un abbraccio di tre quarti d’ora.
D: Milo, ci sono degli altri particolari che adesso ti sono venuti in mente sia dell’arresto, della carcerazione o della tua deportazione nel campo di Bolzano?
R: Più o meno a grandi linee ti ho detto tutto. No, direi di no. La mia è stata… Si fosse risolta così anche quella del mio vecchio, sarebbe stato niente. Nel mio caso a parte il morale, quello che ti sentivi dentro, la bomba dentro, però fisicamente io non ho sofferto.
Fame, un po’ di fame, va beh, diavolo, capirai bene cos’è. Botte non ne ho prese, la fame vera non l’ho fatta, una cuccia per dormire ce l’avevo, non mi spaccavano l’anima per lavorare perché non mi hanno fatto lavorare. Per cui a conti fatti avevo il coso dentro, d’accordo, però sofferenze fisiologiche io obiettivamente non ne ho avute. L’ho sempre detto questo. Non è che debba vantare adesso, chi è venuto giù da Bolzano raccontando sono balle, balle sacrosante. Chi s’è fatto grande con un po’ di sofferenze, qualcuno lo conosco anch’io. “Perché noi, sapessi, ci facevano..”. Non ci facevano una madonna, non ci hanno fatto niente. E’ stata una segregazione e basta, non di più.
- scarica la testimonianza (47.93kb – PDF)
- » Navasa Milo: testimonianza sonora (36′) (4269.29kb – MP3)